Una legge elettorale peggiore del Porcellum. La “ghigliottina” per zittire il Parlamento. La vergogna del decreto IMU-Banca d’Italia. Un presidente della Repubblica non più super partes. Queste giornate di fine gennaio saranno ricordate come macchie scure nella vicenda del nostro sistema democratico.
di Angelo d’Orsi (MicroMega)
Ci lamentavamo di Bersani? Becchiamoci Renzi! Qualcuno annunciava la spaccatura del PD. Fassina e Cuperlo hanno appena aderito a tutto, il giovin Civati tace, mi pare. I bersaniani mordono il freno, forse, ma solo per odio a chi ha fatto cadere il loro ex leader. Gli altri “vecchi” della nomenclatura, attendono tempi migliori, badando a non esporsi troppo, usando parole vuote, ma piene di retorica. Come lo erano quelle che abbiamo udito da parte dei rappresentanti di M5S e dei loro contendenti PD, nelle deprimenti zuffe parlamentari: intendiamoci, che la signora Boldrini debba ora menare scandalo per quel che accade nel consesso da lei presieduto (certo, abbiamo avuto Irene Pivetti presidente, e dunque la Boldrini è una gran donna e una politica straordinaria, ma che pena, la sua retorica al servizio del potere!) suona bizzarro, avendo lei inferto un colpo quasi mortale alla dialettica parlamentare, con il ricorso alla “ghigliottina”, per bloccare il dibattito e far convertire in legge, obtorto collo, il vergognosissimo decreto IMU-Banca d’Italia.
Si era mai visto qualcosa di simile in quell’aula? A mia memoria, no. Mentre la storia parlamentare repubblicana è traboccante di incidenti, anche gravi, comprese ingiurie, colluttazioni e addirittura lanci di oggetti (narrano le cronache parlamentari di un deputato comunista che, negli anni Cinquanta, dopo aver con forza erculea divelto un seggio l’abbia scagliato verso i democristiani). Ma devo dire che di tutte le scenette a cui abbiamo assistito per me la più grottesca è stata il faccia a faccia tra due deputati, un PD e un M5S, che ripetevano, psittacisticamente, insomma, come due pappagalli ammaestrati, frasi senza senso, ossia di repertorio, che ricordavano i famigerati “Capra! Capra! Capra!” e via seguitando dell’orrido Sgarbi nei programmi spazzatura della televisione.
L’iterazione è, come si sa, un espediente cui si ricorre in mancanza di capacità argomentativa: certo, che l’onorevole Speranza, col suo faccino compunto da bravo scolaretto, che ripete con voce tesa al suo contendente il mantra “Voi state ostacolando la democrazia” appariva ridicolo, a dir poco: ma nessuno gli ha spiegato che l’ostruzionismo è una tattica parlamentare alle quali tutte le forze politiche hanno fatto e fanno ricorso? Nessuno gli ha detto che la sinistra è stata, lodevolmente, maestra in tale genere di tattica, per fermare provvedimenti liberticidi, o nemici delle classi popolari?
E che dire della reazione generale di scandalo, perché qualcuno osa dire che Napolitano si sta comportando più da capo di governo che da capo di Stato? Si tratta di una osservazione persino banale, che una gran parte dei commentatori indipendenti tanto in patria quanto all’estero ha avuto modo di fare. L’abbiamo scritto anche noi, di MicroMega, qui, più volte, su questo spazio; e l’ho sostenuto io stesso. E ancora per quanto concerne l’inclita signora Boldrini, sia consentito rilevare che, accanto alle solenni reprimende della certamente indecorosa seduta parlamentare, non ha trovato modo di dire una parola di solidarietà per la collega deputata (forse perché di M5S?) duramente colpita da un energumeno di “Scelta civica”, al quale forse si dovrebbe insegnare un po’ di civismo. Ma più ancora offende il fatto che ella, come del resto il presidente della Repubblica, e il presidente del Senato, si comportino come parte integrante dell’Esecutivo: la giustificazione data dalla Boldrini che il suo stop alla discussione aveva il solo scopo di impedire che “gli italiani” (quali? E in quale misura?), pagassero la seconda rata dell’IMU è una offesa alla decenza. E si potrebbe seguitare.
Stiamo, in sintesi, assistendo alla formazione di un blocco storico, mai visto nella vicenda nazionale, neppure ai tempi bui del fascismo: un blocco che cancella le differenze di ruoli tra le istituzioni (Esecutivo e Legislativo diventano tutt’uno), che elimina le diversità delle opzioni politiche (PD-FI e il resto della minuteria “moderata” ormai vanno verso una identità sostanziale, con leggere sfumature che hanno il mero scopo di preservare una identità ai fini elettorali), che toglie persino il velo alla relazione strettissima tra potentati economico-finanziari e apparati politici.
E ancora: come possiamo ancora distinguere la CGIL (di CISL e UIL manco vale la pena di parlare, tanto appiattiti sono ormai da anni sulle logiche padronali) dalla voce del padrone? Il decreto per la “ricapitalizzazione” della Banca d’Italia, che implica un gigantesco regalo alle grandi banche, è un esempio paradigmatico; come lo è il silenzio ossequiente verso le scellerate scelte “strategiche” di Marchionne e dell’”azionista di riferimento” Fiat (Agnelli-Elkann), che meriterebbero risposte adeguate, e così via, non dimenticando la vicenda degli F35 (appena dichiarati pericolosi e costosi dal Pentagono! Mentre il governo Letta, quello “virtuoso”, persevera nella politica delle commesse alle multinazionali produttrici di questi giocattoli di guerra), o quella del TAV, o del MUOS, eccetera eccetera.
Insomma, un catalogo di orrori che sta facendo toccare con mano quanto fossero esatte le funeste previsioni all’ascesa alla guida del PD del giovane rottamatore, che sta inanellando una vittoria dopo l’altra, nel silenzio complice o inerte degli uni, o nell’adesione convinta o necessitata degli altri. Ma le vittorie di Renzi sono altrettante sconfitte della democrazia. E le giornate di fine gennaio saranno ricordate come macchie scure nella vicenda dello stesso sistema liberal-democratico. E non certo per i chiassosi e spesso rozzi, spessissimo irritanti e ignoranti “grillini”, ma per il delitto perfetto che è stato consumato dai “democratici” Renzi e Letta, sotto la regia di Napolitano, con la benevolenza istituzionale dei presidenti delle Camere, e soprattutto la complicità attiva e interessatissima del riesumato Berlusconi e della sua gang.
Ora non paghi di una legge elettorale che, come è stato notato, è persino peggiore della precedente (il “Porcellum” da tanti vituperato, e ora imitato), e prelude a uno scenario cimiteriale, dove due partitoni indistinguibili, come sovente sono laburisti e conservatori in Gran Bretagna, democratici e repubblicani negli Usa, occuperanno l’intero panorama politico. E questa sarebbe la “moderna democrazia” a cui si vuole arrivare? Ma non basta: una nuova gioiosa macchina da guerra avanza. La guida il piccolo duce, alias Renzi, nello stupefatto balbettio della minoranza interna, nella soddisfazione di chi l’ha votato, stanco dell’immobilismo bersaniano, e, infine, nell’entusiasmo di chi lo chiama “Matteo” e lo acclama come la star da opporre finalmente al Berlusconi, e capace di fermare il “fenomeno Grillo”.
Guadagnato il fortilizio elettorale, con una ultima ignominiosa correzione per impedire che la Lega Nord (un partito che proclama la secessione dall’Italia!) esca dal giro, la macchina marcia verso la Costituzione, che da almeno tre decenni i soloni del “novitismo”, delle “riforme” e della “governabilità”, hanno classificato come “obsoleta”: e in quattro e quattr’otto lo si farà, recando una ferita che non sarà più possibile rimarginare, neppure quando ci si liberasse del Berluscone e del Berluschino. Occorrerà una rivoluzione (si penserà poi all’etichetta), per restituire dignità al Paese e valore alle sue leggi, rinnovando completamente la sua classe dirigente. Ma dietro l’angolo la rivoluzione non si vede: si vedono proteste, jacqueries, ribellioni, uno scontento generale e gigantesco che si traduce anche, per fortuna, in atti di resistenza, che, in realtà numerosissimi e diffusi, hanno il solo torto di non essere coordinati e spesso neppure conosciuti.
Il che vuol dire che davanti a questo sfascio, se si prende atto che l’alternativa tra PD e tutta l’ammucchiata di centrodestra è ormai fasulla, non solo ribellarsi è giusto ma è anche possibile. Lo è perché M5S non rappresenta l’alternativa, e al di là delle simpatie che si possano provare per il movimento, o quanto meno per talune delle sue istanze, o delle idiosincrasie per i due capetti che lo tengono (finora) in pugno, o del fastidio per tanti suoi ridicoli esponenti (basti pensare a Vito Crimi, degno del senatore Razzi imitato dal comico Crozza), ebbene, oggi solo questi ragazzacci stanno provando ad alzare la voce contro lo schifo, anche se poi essi stessi per tanti versi ne sono contaminati. Stanno “facendo ammuina”, certo, ed è poco, e spesso insopportabile nei modi, nelle volgarità, nelle manifestazioni di ignoranza; ma è meglio di nulla. E mentre siamo disgustati di aver sentito il canto di Bella ciao, sulle bocche dei deputati piddini, per difendere il decreto IMU-Bankitalia, certo non ci è piaciuto il “Boia chi molla!”, dei “grillini”, Eppure, come è stato osservato da Alessandro Gilioli: “È davvero notevole lo sforzo con cui il Pd, Forza Italia, Boldrini e Napolitano stanno trasportando verso il Movimento 5 Stelle anche gli italiani meno attratti da Grillo e Casaleggio”.
Ciò malgrado, noi, noi che, schierati da sempre contro il berlusconismo, cancro morale del Paese, noi che non siamo disposti ad andare all’abbraccio con Grillo e Casaleggio, noi che siamo schifati di tutte le scelte del Partito Democratico, noi che siamo delusi di un Vendola rimasto capace di affabulare solo se stesso allo specchio, noi che abbiamo atteso finora invano un gesto serio (di autocritica e di rilancio unitario) da parte dei responsabili della ”vera sinistra” rimasti in posizione perlopiù autoreferenziale, noi che faremo? Ci rifugeremo nell’astensionismo, decidendo di abbandonare le istituzioni nelle grinfie di lorsignori? O addirittura smetteremo di pensare politicamente, rifugiandoci ciascuno nel suo proprio cenobio?
Forse ora, non in attesa di tempi migliori, ma decisi a costruirli, quei tempi, ci tocca, ancora una volta, ricominciare il gramsciano lavorio lungo e tenace, a carattere culturale, ma non soltanto; occorre anche lavorare sul terreno sociale, dando ciascuno il suo modesto contributo per connettere le tante isole di opposizione allo schifo. Un’altra Italia esiste, insomma. E non è così piccola e debole, non ancora. Perciò anche se questa battaglia forse è già perduta, la guerra continua e il combattimento va rilanciato subito, prima che ci schiaccino completamente. E, resistendo allo scoramento, occorre provare ancora una volta a rimettere insieme i pezzi di ciò che sinistra significa o dovrebbe significare, mettendo da parte diffidenze e preclusioni, e sottolineando ciò che deve unire quanti sono contro lorsignori: la situazione è grave, non diamo una mano al nemico.
I link ai giornali degli articoli spesso cambiano e diventa difficile se non impossibile recuperare i testi ai quali si riferivano. Questo è l'archivio on-line del blog Giornale-NOTIZIEOGGI
31.1.14
La legge elettorale salva-Casta e la rottamazione della democrazia
Raniero La Valle (MicroMega)
Ha fatto presto Berlusconi a innalzare il suo trofeo: queste – ha detto – non sono le riforme di Renzi, sono le mie riforme, che io perseguo da vent’anni, fin dalla mia discesa in campo. E Renzi si è vantato di aver fatto in un mese ciò che gli altri non erano riusciti a fare per vent’anni; gli altri, cioè, appunto, Berlusconi.
Sicché non a torto i costituzionalisti, criticando la legge elettorale presentata dai due, e giudicandola peggiore del “Porcellum”, hanno scritto che “l’abilità del segretario del PD è consistita nell’essere riuscito a far accettare alla destra più o meno la vecchia legge elettorale da essa varata nel 2005 e oggi dichiarata incostituzionale”.
Nel trofeo innalzato dall’uno e dall’altro non c’è però solo la legge elettorale, c’è anche l’abolizione del Senato e la modifica dell’ordinamento costituzionale delle Regioni. Che poi davvero queste tre riforme vadano in porto è tutto da vedere: gli emendamenti piovono copiosi, l’accordo PD-Forza Italia è presentato come un prendere o lasciare, e con questi metodi prepotenti così lontani dalla mediazione politica, diventa molto probabile che si sfasci tutto, a cominciare dal governo.
In ogni caso, fatta la legge, c’è chi vorrebbe subito usarla per andare a votare; ma questa legge non lo permette, a meno di sprofondare nel caos. Ancora nessuno lo ha detto, ma finché c’è il Senato, che ha un elettorato diverso per età da quello della Camera, c’è il rischio di due risultati difformi nei due rami del Parlamento: o che il premio di maggioranza nella Camera dei deputati vada a una coalizione diversa ed opposta rispetto a quella del Senato, o che scatti al primo turno per una Camera e solo col ballottaggio per l’altra: altro che sapere la sera stessa delle elezioni chi ha vinto e governa!
A noi interessa però guardare un po’ più lontano nel futuro, e intanto cercare di capire perché Berlusconi, Renzi e il Partito Democratico abbiano concordato e fatto proprie queste tre riforme.
Per quanto riguarda Berlusconi è chiaro. Il “Porcellum” è un diritto illegittimo, perché in contrasto con la Costituzione; ma solo con un diritto illegittimo, che trasforma una minoranza nell’unica forza dominante in Parlamento, a fronte di un’opposizione ridotta di numero e resa impotente, si può realizzare il progetto di un capo populista della destra che diventa padrone di tutto lo Stato. Il cosiddetto “Italicum”, ad onta della sentenza della Corte costituzionale, riproduce, aggravato, questo modello di diritto illegittimo.
Anche nella forma esso non si presenta come una nuova legge elettorale, ma come la vecchia legge corretta per via di emendamenti; come tale lascia intatta la logica del “Porcellum”, e in particolare lascia in vigore l’art. 14 bis che tendeva a ridurre la costellazione politica, sia pure bipolare, a due soli partiti. Infatti esso pretende che i partiti che confluiscono in una coalizione perdano qualsiasi identità ed autonomia: essi devono avere lo stesso programma del partito maggiore, lo stesso capo (anche se interdetto?) e se non superano una certa soglia di voti non hanno diritto ad entrare con propri rappresentanti in Parlamento. Insomma Alfano deve avere per capo Berlusconi e Vendola Renzi.
Salvo modifiche che possano essere portate all’ultima ora (ma dai suoi proponenti il testo è stato presentato come blindato) il progetto Renzi-Berlusconi innalza la soglia di sbarramento per i partiti coalizzati dal 2 al 5 per cento[1], e quella per i partiti non coalizzati al livello proibitivo dell’8 per cento dei voti (impossibile da raggiungere anche per la Lega). Le coalizioni, poi, per essere ammesse alla ripartizione dei seggi, dovrebbero avere almeno il 12 per cento dei suffragi, che altrimenti diventano inutili.
A questa prima distorsione del risultato si aggiunge il premio di maggioranza che sarebbe dato, al primo turno o al ballottaggio, al partito o alla coalizione che abbia raggiunto il 35 per cento dei voti (che Berlusconi non vuole alzare perché conta di vincere al primo turno[2]) e che otterrebbe tra il 53 e il 55 per cento dei seggi. Ciò renderebbe del tutto sproporzionato, contro la sentenza della Corte, il rapporto tra voti conseguiti e seggi assegnati, alterando irrimediabilmente la rappresentanza. Di più, nel nuovo “Porcellum” c’è la conferma delle liste bloccate, anche se più corte, senza alcuna possibilità di scelta da parte dei cittadini.
Così configurata, la nuova legge elettorale distrugge il pluralismo politico, e cioè lo specifico della democrazia; non solo toglie i cespugli, cioè – come dice Renzi – libera i partiti maggiori dal “ricatto dei piccoli partiti”, ma toglie tutti gli alberi del bosco lasciandone solo uno a dominare il deserto e un altro, mutilato e umiliato, a riceverne l’ombra come parte di un unico sistema. In tal modo le elezioni invece che essere una scelta tra diverse opzioni politiche per il governo del Paese, si trasformano in una successione ereditaria per la quale il potere già esistente perpetua se stesso aggiornando di volta in volta per cooptazione le nomenclature al comando nei due partiti. Dopo tante invettive contro la casta una legge più castale di così non si poteva immaginare.
Quanto al Senato è evidente l’interesse di Berlusconi ad abolirlo: dal suo punto di vista non solo la Camera Alta, ma tutto il Parlamento è una spesa inutile; per la Camera aveva già detto che basterebbe che si riunissero i capigruppo per decidere ogni cosa, e quanto al rapporto di fiducia col governo non c’è nessun bisogno del Parlamento, basta la fiducia dei cittadini. Riguardo poi al titolo V della Costituzione se il Senato e i partiti sono enti inutili, figurarsi se ci si può far scrupolo delle Regioni, che di tutto il sistema sono le peggio riuscite.
Ma se per Berlusconi le ragioni di queste scelte sono chiare, non lo sono affatto per Renzi. La sua dovrebbe essere un’altra cultura; certo potrebbero influire l’inesperienza dell’età, la presunzione del narcisismo, la malagrazia nei rapporti personali, soprattutto con i dissenzienti, l’azzardo del gioco politico, ma un segretario del PD che d’accordo con Berlusconi crei le condizioni per l’instaurazione del regime berlusconiano non è spiegabile. Finora ciò è stato impedito dalla resistenza della Costituzione, dal controllo di legittimità della magistratura, dalle scelte, anche referendarie, dell’elettorato, dall’opposizione delle forze democratiche e dello stesso PD; ed ecco che ora al regime interdetto viene di nuovo spalancata la porta del potere: “con questa legge – ha detto Brunetta – stravinciamo”.
Probabilmente ciò di cui è vittima Renzi è la sindrome del Truman-show, del reality, per cui crede che quello che appare in televisione c’è nella realtà; e in televisione c’è il mito Renzi, il vincitore, e crede che questo mito non possa avere smentite.
Resta da chiedersi perché il Partito Democratico è entrato in questa fase di rottamazione. Non è vero che la sua classe dirigente anelasse da anni a queste riforme per restare sola al comando. C’era anzi l’idea di essere eredi di un’investitura nobiliare da salvatori della democrazia. Però si è aperto un vuoto. C’è stata una rottura più forte di quella provocata dalla “vocazione maggioritaria” di Veltroni, c’è stata la perdita delle sue culture. Il Partito Democratico ne aveva raccolte due: della cultura comunista aveva buttato l’acqua sporca insieme al bambino, restando privo di economia politica; della cultura cattolica aveva intercettato solo i residui della versione democristiana, restando irraggiungibile dalle novità della Chiesa conciliare e tanto più, ora dalla critica di sistema di papa Francesco.
Se queste sono le ragioni del disastro, le ragioni della rinascita possono essere solo nell’avvento di nuove culture politiche e di nuovi partiti. Senza cultura e senza partiti la democrazia non si fa. Ma essi devono essere all’altezza di una vocazione europea e mondiale e pari alla sfida della incalzante controrivoluzione postnovecentesca.
NOTE
[1] Un ulteriore accordo tra Renzi e Berlusconi ha previsto un piccolo sconto in questo sbarramento, dal 5 al 4,5 per cento.
[2] Nel nuovo accordo con Renzi Berlusconi ha concesso di portare la soglia per il premio di maggioranza dal 35 al 37 per cento.
Ha fatto presto Berlusconi a innalzare il suo trofeo: queste – ha detto – non sono le riforme di Renzi, sono le mie riforme, che io perseguo da vent’anni, fin dalla mia discesa in campo. E Renzi si è vantato di aver fatto in un mese ciò che gli altri non erano riusciti a fare per vent’anni; gli altri, cioè, appunto, Berlusconi.
Sicché non a torto i costituzionalisti, criticando la legge elettorale presentata dai due, e giudicandola peggiore del “Porcellum”, hanno scritto che “l’abilità del segretario del PD è consistita nell’essere riuscito a far accettare alla destra più o meno la vecchia legge elettorale da essa varata nel 2005 e oggi dichiarata incostituzionale”.
Nel trofeo innalzato dall’uno e dall’altro non c’è però solo la legge elettorale, c’è anche l’abolizione del Senato e la modifica dell’ordinamento costituzionale delle Regioni. Che poi davvero queste tre riforme vadano in porto è tutto da vedere: gli emendamenti piovono copiosi, l’accordo PD-Forza Italia è presentato come un prendere o lasciare, e con questi metodi prepotenti così lontani dalla mediazione politica, diventa molto probabile che si sfasci tutto, a cominciare dal governo.
In ogni caso, fatta la legge, c’è chi vorrebbe subito usarla per andare a votare; ma questa legge non lo permette, a meno di sprofondare nel caos. Ancora nessuno lo ha detto, ma finché c’è il Senato, che ha un elettorato diverso per età da quello della Camera, c’è il rischio di due risultati difformi nei due rami del Parlamento: o che il premio di maggioranza nella Camera dei deputati vada a una coalizione diversa ed opposta rispetto a quella del Senato, o che scatti al primo turno per una Camera e solo col ballottaggio per l’altra: altro che sapere la sera stessa delle elezioni chi ha vinto e governa!
A noi interessa però guardare un po’ più lontano nel futuro, e intanto cercare di capire perché Berlusconi, Renzi e il Partito Democratico abbiano concordato e fatto proprie queste tre riforme.
Per quanto riguarda Berlusconi è chiaro. Il “Porcellum” è un diritto illegittimo, perché in contrasto con la Costituzione; ma solo con un diritto illegittimo, che trasforma una minoranza nell’unica forza dominante in Parlamento, a fronte di un’opposizione ridotta di numero e resa impotente, si può realizzare il progetto di un capo populista della destra che diventa padrone di tutto lo Stato. Il cosiddetto “Italicum”, ad onta della sentenza della Corte costituzionale, riproduce, aggravato, questo modello di diritto illegittimo.
Anche nella forma esso non si presenta come una nuova legge elettorale, ma come la vecchia legge corretta per via di emendamenti; come tale lascia intatta la logica del “Porcellum”, e in particolare lascia in vigore l’art. 14 bis che tendeva a ridurre la costellazione politica, sia pure bipolare, a due soli partiti. Infatti esso pretende che i partiti che confluiscono in una coalizione perdano qualsiasi identità ed autonomia: essi devono avere lo stesso programma del partito maggiore, lo stesso capo (anche se interdetto?) e se non superano una certa soglia di voti non hanno diritto ad entrare con propri rappresentanti in Parlamento. Insomma Alfano deve avere per capo Berlusconi e Vendola Renzi.
Salvo modifiche che possano essere portate all’ultima ora (ma dai suoi proponenti il testo è stato presentato come blindato) il progetto Renzi-Berlusconi innalza la soglia di sbarramento per i partiti coalizzati dal 2 al 5 per cento[1], e quella per i partiti non coalizzati al livello proibitivo dell’8 per cento dei voti (impossibile da raggiungere anche per la Lega). Le coalizioni, poi, per essere ammesse alla ripartizione dei seggi, dovrebbero avere almeno il 12 per cento dei suffragi, che altrimenti diventano inutili.
A questa prima distorsione del risultato si aggiunge il premio di maggioranza che sarebbe dato, al primo turno o al ballottaggio, al partito o alla coalizione che abbia raggiunto il 35 per cento dei voti (che Berlusconi non vuole alzare perché conta di vincere al primo turno[2]) e che otterrebbe tra il 53 e il 55 per cento dei seggi. Ciò renderebbe del tutto sproporzionato, contro la sentenza della Corte, il rapporto tra voti conseguiti e seggi assegnati, alterando irrimediabilmente la rappresentanza. Di più, nel nuovo “Porcellum” c’è la conferma delle liste bloccate, anche se più corte, senza alcuna possibilità di scelta da parte dei cittadini.
Così configurata, la nuova legge elettorale distrugge il pluralismo politico, e cioè lo specifico della democrazia; non solo toglie i cespugli, cioè – come dice Renzi – libera i partiti maggiori dal “ricatto dei piccoli partiti”, ma toglie tutti gli alberi del bosco lasciandone solo uno a dominare il deserto e un altro, mutilato e umiliato, a riceverne l’ombra come parte di un unico sistema. In tal modo le elezioni invece che essere una scelta tra diverse opzioni politiche per il governo del Paese, si trasformano in una successione ereditaria per la quale il potere già esistente perpetua se stesso aggiornando di volta in volta per cooptazione le nomenclature al comando nei due partiti. Dopo tante invettive contro la casta una legge più castale di così non si poteva immaginare.
Quanto al Senato è evidente l’interesse di Berlusconi ad abolirlo: dal suo punto di vista non solo la Camera Alta, ma tutto il Parlamento è una spesa inutile; per la Camera aveva già detto che basterebbe che si riunissero i capigruppo per decidere ogni cosa, e quanto al rapporto di fiducia col governo non c’è nessun bisogno del Parlamento, basta la fiducia dei cittadini. Riguardo poi al titolo V della Costituzione se il Senato e i partiti sono enti inutili, figurarsi se ci si può far scrupolo delle Regioni, che di tutto il sistema sono le peggio riuscite.
Ma se per Berlusconi le ragioni di queste scelte sono chiare, non lo sono affatto per Renzi. La sua dovrebbe essere un’altra cultura; certo potrebbero influire l’inesperienza dell’età, la presunzione del narcisismo, la malagrazia nei rapporti personali, soprattutto con i dissenzienti, l’azzardo del gioco politico, ma un segretario del PD che d’accordo con Berlusconi crei le condizioni per l’instaurazione del regime berlusconiano non è spiegabile. Finora ciò è stato impedito dalla resistenza della Costituzione, dal controllo di legittimità della magistratura, dalle scelte, anche referendarie, dell’elettorato, dall’opposizione delle forze democratiche e dello stesso PD; ed ecco che ora al regime interdetto viene di nuovo spalancata la porta del potere: “con questa legge – ha detto Brunetta – stravinciamo”.
Probabilmente ciò di cui è vittima Renzi è la sindrome del Truman-show, del reality, per cui crede che quello che appare in televisione c’è nella realtà; e in televisione c’è il mito Renzi, il vincitore, e crede che questo mito non possa avere smentite.
Resta da chiedersi perché il Partito Democratico è entrato in questa fase di rottamazione. Non è vero che la sua classe dirigente anelasse da anni a queste riforme per restare sola al comando. C’era anzi l’idea di essere eredi di un’investitura nobiliare da salvatori della democrazia. Però si è aperto un vuoto. C’è stata una rottura più forte di quella provocata dalla “vocazione maggioritaria” di Veltroni, c’è stata la perdita delle sue culture. Il Partito Democratico ne aveva raccolte due: della cultura comunista aveva buttato l’acqua sporca insieme al bambino, restando privo di economia politica; della cultura cattolica aveva intercettato solo i residui della versione democristiana, restando irraggiungibile dalle novità della Chiesa conciliare e tanto più, ora dalla critica di sistema di papa Francesco.
Se queste sono le ragioni del disastro, le ragioni della rinascita possono essere solo nell’avvento di nuove culture politiche e di nuovi partiti. Senza cultura e senza partiti la democrazia non si fa. Ma essi devono essere all’altezza di una vocazione europea e mondiale e pari alla sfida della incalzante controrivoluzione postnovecentesca.
NOTE
[1] Un ulteriore accordo tra Renzi e Berlusconi ha previsto un piccolo sconto in questo sbarramento, dal 5 al 4,5 per cento.
[2] Nel nuovo accordo con Renzi Berlusconi ha concesso di portare la soglia per il premio di maggioranza dal 35 al 37 per cento.
Etichette:
Berlusconi,
democrazia,
La Valle,
legge elettorale,
Micromega,
PD,
Renzi
29.1.14
L'urlo dell'Ucraina, il silenzio dell'Europa
Barbara Spinelli (repubblica.it)
A prima vista sembra un vasto e violento tumulto in favore dell'Europa, quello che da mesi sconvolge l'Ucraina. Un tumulto che ci sorprende, ci scombussola: possibile che l'Unione accenda le brame furiose di un popolo, proprio ora che tanti nostri cittadini la rigettano?
È possibile, ma a condizione di decifrare l'insurrezione: di esplorarne i buchi neri, gli anfratti. Di capire che la dimissione del premier Azarov non metterà fine alla rabbia, all'anarchia. A condizione di non consegnare l'Ucraina al nero della solitudine e mantenere però la mente fredda: che analizza, distingue la superficie visibile dai sottofondi. A condizione che l'Europa sappia di essere non solo simbolo, ma pretesto per abbattere il regime di Kiev. Che diventi motore degli eventi, smettendo di vedere se stessa come Empireo immune da difetti che abbraccia i cieli inferiori ma senza responsabilità. Lo sguardo europeo è attratto dagli esotismi, ed esoticamente lontana è Piazza-Europa, chiamata dagli ucrainiEuromaidan. Incapace di far politica, l'Unione commenta con pietrificati sermoni sui propri valori il film atroce, fatto d'incendi e lividi paesaggi, che vediamo in Tv.
Abbiamo alle spalle anni di esperienze esotiche finite nel caos: le primavere arabe, la Libia, la Siria. Le primavere svegliarono euforie democratiche degenerate in carneficine. Un'analisi di questo radicale fallimento neppure è cominciata: né in Usa né in Europa. Fondata è l'accusa dello scrittore polacco Andrzej Stasiuk sulla Welt: viviamo, noi europei, nella paura di perdere la "roba" e nell'endogamia. La nostra risposta agli squassi ucraini è una patologica coazione a ripetere.
I trattati di psicologia insegnano: sempre ricadiamo nell'identica perversa letargia, intrappolati e sorpresi dagli eventi, quando non riconosciamo di esserne autori. La passività di fronte alla disperazione ucraina ripete quel che non sappiamo: imparare, fare autocritica, trasformarci.
Eppure gli elementi dell'immane complicazione di Kiev sono visibili. Sempre più, la protesta contro il regime di Yanukovich assume tratti spurî, inevitabili in un paese immerso in guerre civili perché reietto. L'ira esplose il 21 novembre, quando Kiev rinunciò al trattato di associazione con l'Unione per timore di perdere Putin, che sarà un semi-dittatore ma garantiva più aiuti dell'Europa, e contratti promettenti in materie vitali: le forniture d'energia. Dopodiché tutto s'è sbrindellato sfociando nel sangue, proprio come nelle primavere arabe (4 attivisti morti). L'insurrezione è senza leader e programmi stabili.
Nel suo torrente nuotano anche gli ultra-nazionalisti, raccontano i reporter, ma l'aggettivo è eufemistico. Anche se minoritarie, due destre estreme sono protagoniste: la formazione Svoboda, nata da un partito neonazista che inneggia a Stepan Bandera (collaborazionista di Hitler nella guerra) e che ancora nel 2004 si definiva social-nazionale, avendo come emblema una specie di svastica; e il "Settore di destra" (Pravi Sektor), che rischia di alterare un movimento in principio liberal-democratico. La russofobia, dunque il razzismo, le impregna. Mark Ferretti del Sunday Times lo scrive sulla Stampa: per tanti, "l'integrazione nell'Unione europea non è la priorità". Non basterà la revoca, ieri, delle leggi liberticide del 16 gennaio.
L'inerzia dell'Unione europea risale ai tempi dell'allargamento. Già allora ci si concentrò su regole finanziarie e giuridiche, e mancò la politica come sintesi: che difendesse la natura federale dell'Unione in modo da frenare i nazionalismi dell'Est, e costruisse un rapporto non sconclusionato con la Russia e le zone di mezzo fra lei e noi (l'"estero vicino", si chiama a Mosca: è "estero vicino" anche per noi). Una Russia influenzata certo dal passato (Putin ritiene una "catastrofe storica" la fine dell'impero sovietico, che sogna di restaurare), ma un paese mutante, col quale nessun discorso serio si apre perché sempre l'Europa aspetta - per comoda abulia, per vizi contratti in guerra fredda - che la prima mossa sia americana.
Quel che colpisce nel no di Kiev a Bruxelles dovrebbe farci pensare: proprio perché nuovo, frastornante. Perché il tumulto non ci dà automaticamente ragione, se l'Europa è un pretesto. Inutile perdersi in descrizioni di un'Ucraina ancora erede dell'ex Urss, e malefico sarebbe tollerare passioni torbide come la russofobia. Utile è riconoscere invece che l'era degli allargamenti è conclusa, che le adesioni o associazioni esterne fanno oggi problema. Perché quel che offre l'Unione, in tempi di recessione e di crisi che non sa sormontare, attrae enormemente ma anche respinge: sono così lontani, i frutti. L'Europa innalza muri di cinta e la Russia no, quali che siano i suoi colonialismi. C'è poco da compiacersi. La disfatta è nostra.
Se l'Unione è colma di vizi di costruzione, è perché alcune domande essenziali neanche se le pone, neanche sospetta che interrogarsi e mettersi in questione sia già un inizio di buona risposta. Ad esempio: dove finisce l'Europa e dove precisamente comincia l'Est? Cosa vuol dire confine, e l'Estero Vicino? E quali sono i criteri che permettono di affrontare il dramma di un popolo che vuole l'Europa ma in parte anche la respinge, temendo di accentuare la propria crisi infilandosi nella sua orbita?
Qui è il guaio: l'Europa assiste a simili terremoti come se fosse non un attore politico ma un semplice contenitore, una sorta di hotel degli Stati e dei popoli. L'allargamento nel 2004-2007 avvenne inscatolando, non integrando, e l'Unione non ne uscì rafforzata ma svuotata. I nuovi Stati, esclusa la Polonia a partire dal 2010, non hanno capito l'Unione in cui entravano: la scambiarono appunto per un recipiente, che invitava a trasferire sovranità nazionali verso l'ignoto, non verso un'autorità comune, solidale, forte di un'autentica politica estera. L'Ucraina è piena di buchi neri, ma anche noi. Ha vinto la ricetta britannica: mera custode di parametri finanziari, l'Unione è un'area di libero scambio, non una potenza politica.
Non stupisce che gli inviati europei a Kiev (Catherine Ashton, incaricata dei rapporti esterni, è una delle persone più scialbe dell'Unione)siano completamente muti. Che Van Rompuy, A parte questo: nulla. Sono andati alla Piazza di Kiev politici Usa (Victoria Nuland vice segretario di Stato, i senatori John McCain, Chris Murphy) ma nessun politico europeo di rilievo. Non per questo gli Stati dell'Unione sono assenti. Angela Merkel è molto attiva: sostiene un oppositore del regime di Kiev, l'ex pugile Vitaly Klitschko, ma solo per immetterlo nel Partito popolare europeo e punzecchiare Putin senza un piano generale. Ancora una volta non è l'Unione a muoversi, ma il paese geopoliticamente più interessato, e forte.
In Europa si coltiva l'idea, esiziale, che prima viene l'economia, e chissà quando la politica estera. È una delle sue più gravi menomazioni. Avere
una politica estera, nel Mediterraneo e in una Russia pensata oltre Putin, implica collocarsi nel mondo come soggetto politico, non come finanziere o commerciante. Accodarsi a Washington significa condividere un destino di guerre perse, di potenza non più egemonica e solo nazionalista, impreparata a pensare un mondo i cui attori sono oggi molteplici. Un destino che mescola valori altisonanti e calcoli economici, creando guazzabugli. Da questa gabbia conviene uscire al più presto.
A prima vista sembra un vasto e violento tumulto in favore dell'Europa, quello che da mesi sconvolge l'Ucraina. Un tumulto che ci sorprende, ci scombussola: possibile che l'Unione accenda le brame furiose di un popolo, proprio ora che tanti nostri cittadini la rigettano?
È possibile, ma a condizione di decifrare l'insurrezione: di esplorarne i buchi neri, gli anfratti. Di capire che la dimissione del premier Azarov non metterà fine alla rabbia, all'anarchia. A condizione di non consegnare l'Ucraina al nero della solitudine e mantenere però la mente fredda: che analizza, distingue la superficie visibile dai sottofondi. A condizione che l'Europa sappia di essere non solo simbolo, ma pretesto per abbattere il regime di Kiev. Che diventi motore degli eventi, smettendo di vedere se stessa come Empireo immune da difetti che abbraccia i cieli inferiori ma senza responsabilità. Lo sguardo europeo è attratto dagli esotismi, ed esoticamente lontana è Piazza-Europa, chiamata dagli ucrainiEuromaidan. Incapace di far politica, l'Unione commenta con pietrificati sermoni sui propri valori il film atroce, fatto d'incendi e lividi paesaggi, che vediamo in Tv.
Abbiamo alle spalle anni di esperienze esotiche finite nel caos: le primavere arabe, la Libia, la Siria. Le primavere svegliarono euforie democratiche degenerate in carneficine. Un'analisi di questo radicale fallimento neppure è cominciata: né in Usa né in Europa. Fondata è l'accusa dello scrittore polacco Andrzej Stasiuk sulla Welt: viviamo, noi europei, nella paura di perdere la "roba" e nell'endogamia. La nostra risposta agli squassi ucraini è una patologica coazione a ripetere.
I trattati di psicologia insegnano: sempre ricadiamo nell'identica perversa letargia, intrappolati e sorpresi dagli eventi, quando non riconosciamo di esserne autori. La passività di fronte alla disperazione ucraina ripete quel che non sappiamo: imparare, fare autocritica, trasformarci.
Eppure gli elementi dell'immane complicazione di Kiev sono visibili. Sempre più, la protesta contro il regime di Yanukovich assume tratti spurî, inevitabili in un paese immerso in guerre civili perché reietto. L'ira esplose il 21 novembre, quando Kiev rinunciò al trattato di associazione con l'Unione per timore di perdere Putin, che sarà un semi-dittatore ma garantiva più aiuti dell'Europa, e contratti promettenti in materie vitali: le forniture d'energia. Dopodiché tutto s'è sbrindellato sfociando nel sangue, proprio come nelle primavere arabe (4 attivisti morti). L'insurrezione è senza leader e programmi stabili.
Nel suo torrente nuotano anche gli ultra-nazionalisti, raccontano i reporter, ma l'aggettivo è eufemistico. Anche se minoritarie, due destre estreme sono protagoniste: la formazione Svoboda, nata da un partito neonazista che inneggia a Stepan Bandera (collaborazionista di Hitler nella guerra) e che ancora nel 2004 si definiva social-nazionale, avendo come emblema una specie di svastica; e il "Settore di destra" (Pravi Sektor), che rischia di alterare un movimento in principio liberal-democratico. La russofobia, dunque il razzismo, le impregna. Mark Ferretti del Sunday Times lo scrive sulla Stampa: per tanti, "l'integrazione nell'Unione europea non è la priorità". Non basterà la revoca, ieri, delle leggi liberticide del 16 gennaio.
L'inerzia dell'Unione europea risale ai tempi dell'allargamento. Già allora ci si concentrò su regole finanziarie e giuridiche, e mancò la politica come sintesi: che difendesse la natura federale dell'Unione in modo da frenare i nazionalismi dell'Est, e costruisse un rapporto non sconclusionato con la Russia e le zone di mezzo fra lei e noi (l'"estero vicino", si chiama a Mosca: è "estero vicino" anche per noi). Una Russia influenzata certo dal passato (Putin ritiene una "catastrofe storica" la fine dell'impero sovietico, che sogna di restaurare), ma un paese mutante, col quale nessun discorso serio si apre perché sempre l'Europa aspetta - per comoda abulia, per vizi contratti in guerra fredda - che la prima mossa sia americana.
Quel che colpisce nel no di Kiev a Bruxelles dovrebbe farci pensare: proprio perché nuovo, frastornante. Perché il tumulto non ci dà automaticamente ragione, se l'Europa è un pretesto. Inutile perdersi in descrizioni di un'Ucraina ancora erede dell'ex Urss, e malefico sarebbe tollerare passioni torbide come la russofobia. Utile è riconoscere invece che l'era degli allargamenti è conclusa, che le adesioni o associazioni esterne fanno oggi problema. Perché quel che offre l'Unione, in tempi di recessione e di crisi che non sa sormontare, attrae enormemente ma anche respinge: sono così lontani, i frutti. L'Europa innalza muri di cinta e la Russia no, quali che siano i suoi colonialismi. C'è poco da compiacersi. La disfatta è nostra.
Se l'Unione è colma di vizi di costruzione, è perché alcune domande essenziali neanche se le pone, neanche sospetta che interrogarsi e mettersi in questione sia già un inizio di buona risposta. Ad esempio: dove finisce l'Europa e dove precisamente comincia l'Est? Cosa vuol dire confine, e l'Estero Vicino? E quali sono i criteri che permettono di affrontare il dramma di un popolo che vuole l'Europa ma in parte anche la respinge, temendo di accentuare la propria crisi infilandosi nella sua orbita?
Qui è il guaio: l'Europa assiste a simili terremoti come se fosse non un attore politico ma un semplice contenitore, una sorta di hotel degli Stati e dei popoli. L'allargamento nel 2004-2007 avvenne inscatolando, non integrando, e l'Unione non ne uscì rafforzata ma svuotata. I nuovi Stati, esclusa la Polonia a partire dal 2010, non hanno capito l'Unione in cui entravano: la scambiarono appunto per un recipiente, che invitava a trasferire sovranità nazionali verso l'ignoto, non verso un'autorità comune, solidale, forte di un'autentica politica estera. L'Ucraina è piena di buchi neri, ma anche noi. Ha vinto la ricetta britannica: mera custode di parametri finanziari, l'Unione è un'area di libero scambio, non una potenza politica.
Non stupisce che gli inviati europei a Kiev (Catherine Ashton, incaricata dei rapporti esterni, è una delle persone più scialbe dell'Unione)siano completamente muti. Che Van Rompuy, A parte questo: nulla. Sono andati alla Piazza di Kiev politici Usa (Victoria Nuland vice segretario di Stato, i senatori John McCain, Chris Murphy) ma nessun politico europeo di rilievo. Non per questo gli Stati dell'Unione sono assenti. Angela Merkel è molto attiva: sostiene un oppositore del regime di Kiev, l'ex pugile Vitaly Klitschko, ma solo per immetterlo nel Partito popolare europeo e punzecchiare Putin senza un piano generale. Ancora una volta non è l'Unione a muoversi, ma il paese geopoliticamente più interessato, e forte.
In Europa si coltiva l'idea, esiziale, che prima viene l'economia, e chissà quando la politica estera. È una delle sue più gravi menomazioni. Avere
Etichette:
Europa,
La Repubblica,
Spinelli,
Ucraina
24.1.14
I sassi nello stagno di Noam Chomsky
Francesco Ferretti (il manifesto)
Festival delle scienze. In occasione dell’incontro che il grande linguista americano avrà domani all’Auditorium di Roma con Andrea Moro, una discussione sulle sue tesi, alle luce delle critiche avanzate da diversi fronti
Quando visitiamo un paese in cui si parla una lingua molto diversa dalla nostra è facile provare un
senso di forte estraneità: la difficoltà di farsi capire e di comprendere ciò che gli altri dicono alimenta
in noi la convinzione che le lingue parlate da comunità diverse siano tra loro molto eterogenee
e che gli individui che appartengono a comunità distinte siano molto diversi tra loro a causa
delle lingue che parlano. Una convinzione di questo tipo, oltre alla plausibilità intuitiva facilmente
esperibile da chiunque, ha dalla sua un modello teorico consolidato: il relativismo culturale.
Poiché a rendere gli umani ciò che sono è la cultura che li distingue e non la biologia che li accomuna,
per i fautori del relativismo culturale l’idea stessa di «natura umana» è fuorviante, se non
addirittura priva di senso: come ebbe a dire Clifford Gertz in Interpretazione di culture (Il Mulino,
1987) «tutto ciò che gli umani hanno in comune è il loro essere profondamente diversi».
Dire che le caratteristiche salienti degli individui dipendono dalla cultura, significa sostenere che gli
individui sono ciò che sono in forza di ciò che apprendono: il linguaggio, per il tratto sociale che lo
caratterizza, è l’esempio principe di questa ipotesi interpretativa.
La conformità dei modelli teorici alle intuizioni del senso comune ha determinato per decenni uno
stato di calma piatta. Poi, all’improvviso, il classico sasso nello stagno ha rotto l’incantesimo causando
un terremoto concettuale. Nel 1959 Chomsky commentò in poche pagine Il comportamento
verbale di Burrhus Skinner (Armando, 2008) dimostrando che l’idea del linguaggio fondata sulla
tabula rasa e sul ruolo costitutivo dell’apprendimento non regge alla prova dei fatti. A fare le spese
della critica di Chomsky, oltre a Skinner, è l’intero movimento teorico da lui rappresentato: se lo
schema stimolo-risposta non spiega il linguaggio umano allora il comportamentismo va bene per
i piccioni o i ratti di laboratorio, non per dar conto della natura degli individui della nostra specie.
Il «problema di Platone»
Da quella recensione in poi, il modo di intendere il linguaggio è cambiato radicalmente. Le capacità
verbali umane sono considerate oggi affare della biologia, prima che della cultura: poiché le lingue
storico-naturali hanno una natura ancillare rispetto alla facoltà di linguaggio, la verbalizzazione
umana è un frammento della mente-cervello, non l’effetto di pratiche comunicative comunitarie. La
variabilità linguistica che appare in tutta evidenza nel visitare paesi assai diversi dal nostro è un
falso indizio di diversità: il contrasto di cui facciamo esperienza riguarda soltanto il codice espressivo,
la struttura di superficie del linguaggio. La sostanza della verbalizzazione umana, tuttavia,
è rintracciabile nella sua struttura profonda, la Grammatica Universale: l’insieme di regole e principi
che governano il funzionamento della mente-cervello nei processi di produzione e comprensione linguistica.
Quando spostiamo l’attenzione dal codice espressivo al dispositivo bio-cognitivo che
governa l’acquisizione e il corretto funzionamento delle nostre capacità verbali, la diversità linguistica
lascia il posto all’idea che il linguaggio sia una caratteristica universale (come la postura
eretta) della nostra specie.
A dar man forte a Chomsky contro il relativismo culturale è l’innatismo del linguaggio: la Grammatica
Universale è un dispositivo di elaborazione presente sin dalla nascita nella mente-cervello degli
umani. Tutto il percorso concettuale di Chomsky, in effetti, può essere considerato una difesa di ciò
che il linguista americano ha chiamato il «problema di Platone»: capire come dar conto di ciò che gli
umani sanno a partire dalle limitate esperienze che hanno. Il linguaggio non può essere spiegato in
termini di apprendimento perché lo stimolo verbale è troppo povero per giustificare le sofisticate
competenze linguistiche di cui (molto presto) dispone il bambino.
Gli argomenti di Chomsky rappresentano un punto di non ritorno: la Grammatica Universale ha chiamato
tutti gli studiosi a una reimpostazione di base del modo di guardare alla comunicazione umana.
Detto questo, la proposta di Chomsky è oggi al centro di una profonda revisione. Il primo fronte di
discussione riguarda il «fuoco amico»: le critiche, mosse da autori interni al paradigma chomskiano,
relative ai rapporti tra la Grammatica Universale e la teoria dell’evoluzione. Dall’altra parte della
barricata un secondo fronte di discussione riguarda la proposta dei neoculturalisti: studiosi che, in
nome della diversità delle lingue, attaccano frontalmente la natura innata e universale del linguaggio
umano. Entrambi i fronti di discussione sollevano questioni di grande importanza per il dibattito contemporaneo
e meritano alcune parole di commento.
Per comprendere le critiche alla Grammatica Universale mosse dal fronte interno, è necessario chiamare
in causa i rapporti che il modello chomskiano intrattiene con la tradizione cartesiana. Per
Chomsky il linguaggio è un fenomeno che non ha eguali in natura: la comunicazione umana (libera
e creativa) risponde a principi affatto diversi da quelli attribuibili alla comunicazione animale (meccanica
e determinata): seguendo Cartesio, Chomsky sostiene che il linguaggio istituisce una «differenza
qualitativa» tra gli individui della nostra specie e gli altri animali. Oltre a rinforzare l’idea
degli umani come entità speciali nella natura, la tesi dell’unicità del linguaggio umano offre a Chomsky
un appiglio per sostenere che il linguaggio non è un adattamento biologico dovuto alla selezione
naturale.
Il tema della complessità
Uno degli argomenti utilizzati da Chomsky contro la selezione naturale è l’idea che il linguaggio sia
«troppo complesso» per poter essere spiegato in termini gradualistici. Il tema della complessità,
come è noto, ha da sempre rappresentato un problema per la teoria dell’evoluzione. Al fondo della
questione è l’argomento degli organi incipienti utilizzato ai tempi di Darwin da St. George Mivart in
On the genesis of species (Mcmillan, 1871): se un’ala allo stato iniziale non permette di volare che
tipo di vantaggio può assicurare a un organismo? Discorso analogo vale per il linguaggio: quale vantaggio
adattativo può rappresentare un frammento iniziale di Grammatica Universale? Poiché senza
una risposta a queste domande non è possibile pensare a un’evoluzione gradualistica degli organi
complessi, la conclusione a cui perviene Chomsky è che la Grammatica Universale sia un dispositivo
tutto-o-nulla difficilmente conciliabile con la selezione naturale. A partire da queste considerazioni,
Chomsky fa propria la proposta avanzata da Ian Tattersall in Il cammino dell’uomo (Garzanti, 2004)
di considerare l’avvento del linguaggio in riferimento alla «teoria dell’esplosione»: secondo Tattersall,
in effetti, le capacità verbali umane sono emerse in modo «improvviso e inaspettato» molto di
recente nella storia di Homo sapiens.
Michael Corballis sostiene in The recursive mind (Princeton University Press, 2011) che considerare
la verbalizzazione umana un fatto improvviso e inaspettato sia un’ipotesi miracolistica che mal si
accorda con l’idea del linguaggio come un organo biologico. A conferma della tesi di Corballis è il
fatto che gli argomenti utilizzati da Chomsky contro la selezione naturale sono gli stessi di quelli
usati da Mivart: ora, come è possibile difendere un approccio naturalistico al linguaggio utilizzando
gli stessi argomenti usati da un fervente creazionista? Criticando aspramente Chomsky su questo
punto, Steven Pinker nel libro L’istinto del linguaggio (Mondadori, 1997) sostiene che, oltre a essere
pienamente compatibile con la Grammatica Universale, la selezione naturale è l’unica spiegazione in
campo (che non sia il creazionismo) per dar conto della complessità del linguaggio.
La risposta di Chomsky non è tardata ad arrivare. Rivedendo le proprie posizioni iniziali
sull’argomento, il linguista americano sostiene oggi che il linguaggio non è così complesso come
potrebbe sembrare: se si guarda al suo componente costitutivo essenziale (la facoltà di linguaggio in
senso stretto), è lecito considerare il linguaggio un’entità piuttosto semplice. Attraverso un’ipotesi
del genere, Chomsky è in grado di superare le difficoltà segnalate dai fautori della concezione adattazionista
del linguaggio senza cedere alle lusinghe di chi lo invita a rivedere il rapporto della Grammatica
Universale con la teoria darwiniana. Con il riferimento alla semplicità del linguaggio Chomsky
apre la strada al «minimalismo» (il suo ultimo modello teorico) convalidando una tendenza che,
storicamente, ha da sempre caratterizzato il suo percorso intellettuale: dagli anni Cinquanta del
Novecento a oggi, i diversi modelli interpretativi proposti da Chomsky sono stati contrassegnati da
un processo continuo di semplificazione. A vantaggio della semplificazione gioca la questione della
plausibilità cognitiva: se la Grammatica Universale descrive i principi alla base del funzionamento
della mente-cervello, allora la Grammatica Universale sarà tanto più plausibile quanto più semplici
ed economici (in termini di energia) saranno i principi che la descrivono. Detto questo, se le difficoltà
sottolineate dagli adattazionisti valgono soltanto per una concezione del linguaggio come un
organo di estrema complessità, attraverso il minimalismo Chomsky guadagna, oltre alla plausibilità
cognitiva, anche la plausibilità evoluzionistica della Grammatica Universale.
La natura della controversia
Il secondo fronte di critiche rispetto alla Grammatica Universale, il versante «neoculturalista», fa di
nuovo appello alla questione della diversità dei codici espressivi. Al tempo delle prime polemiche
contro il relativismo, Chomsky aveva avuto vita facile: i linguisti del tempo non avevano modelli plausibili
delle strutture e dei processi cognitivi implicati nella comunicazione umana. Oggi la situazione
è molto cambiata: nessuno studioso serio pensa di poter affrontare il tema della variabilità dei codici
espressivi senza una prospettiva adeguata dei dispositivi bio-cognitivi coinvolti nell’elaborazione del
linguaggio. Si pensi, solo per citare un esempio, al caso esposto da Michael Tomasello in Le origini
della comunicazione umana (Cortina, 2009) un autore da sempre impegnato nel tentativo di conciliare
gli aspetti culturali del linguaggio con l’idea che la comunicazione umana si avvalga di un ricco
(e in larga parte innato) sistema cognitivo di elaborazione.
Detto questo, la questione controversa è un’altra: più che l’innatismo o la natura universale di certi
dispositivi di elaborazione, il punto in discussione è capire se la Grammatica Universale debba
essere considerata l’unico dispositivo da chiamare in causa per spiegare il linguaggio; se essa sia
soltanto uno dei sistemi implicati nella comunicazione linguistica; o se, nell’ipotesi più radicale, il linguaggio
umano poggi su dispositivi di elaborazione del tutto diversi dalla Grammatica Universale.
La questione è aperta e, al momento, non è chiaro come rispondere al problema. Ciò che appare sensato
sostenere allo stato attuale della ricerca è che, in una prospettiva in cui trovi spazio l’idea del
linguaggio come ibrido bio-culturale, il tema della diversità delle lingue dovrà necessariamente convergere
con la teoria degli universali innati. In una prospettiva di questo tipo, indipendentemente
dalla direzione che prenderà la ricerca in futuro, il dato certo a nostra disposizione è che il confronto
con Chomsky rappresenta comunque un elemento imprescindibile della discussione.
Festival delle scienze. In occasione dell’incontro che il grande linguista americano avrà domani all’Auditorium di Roma con Andrea Moro, una discussione sulle sue tesi, alle luce delle critiche avanzate da diversi fronti
Quando visitiamo un paese in cui si parla una lingua molto diversa dalla nostra è facile provare un
senso di forte estraneità: la difficoltà di farsi capire e di comprendere ciò che gli altri dicono alimenta
in noi la convinzione che le lingue parlate da comunità diverse siano tra loro molto eterogenee
e che gli individui che appartengono a comunità distinte siano molto diversi tra loro a causa
delle lingue che parlano. Una convinzione di questo tipo, oltre alla plausibilità intuitiva facilmente
esperibile da chiunque, ha dalla sua un modello teorico consolidato: il relativismo culturale.
Poiché a rendere gli umani ciò che sono è la cultura che li distingue e non la biologia che li accomuna,
per i fautori del relativismo culturale l’idea stessa di «natura umana» è fuorviante, se non
addirittura priva di senso: come ebbe a dire Clifford Gertz in Interpretazione di culture (Il Mulino,
1987) «tutto ciò che gli umani hanno in comune è il loro essere profondamente diversi».
Dire che le caratteristiche salienti degli individui dipendono dalla cultura, significa sostenere che gli
individui sono ciò che sono in forza di ciò che apprendono: il linguaggio, per il tratto sociale che lo
caratterizza, è l’esempio principe di questa ipotesi interpretativa.
La conformità dei modelli teorici alle intuizioni del senso comune ha determinato per decenni uno
stato di calma piatta. Poi, all’improvviso, il classico sasso nello stagno ha rotto l’incantesimo causando
un terremoto concettuale. Nel 1959 Chomsky commentò in poche pagine Il comportamento
verbale di Burrhus Skinner (Armando, 2008) dimostrando che l’idea del linguaggio fondata sulla
tabula rasa e sul ruolo costitutivo dell’apprendimento non regge alla prova dei fatti. A fare le spese
della critica di Chomsky, oltre a Skinner, è l’intero movimento teorico da lui rappresentato: se lo
schema stimolo-risposta non spiega il linguaggio umano allora il comportamentismo va bene per
i piccioni o i ratti di laboratorio, non per dar conto della natura degli individui della nostra specie.
Il «problema di Platone»
Da quella recensione in poi, il modo di intendere il linguaggio è cambiato radicalmente. Le capacità
verbali umane sono considerate oggi affare della biologia, prima che della cultura: poiché le lingue
storico-naturali hanno una natura ancillare rispetto alla facoltà di linguaggio, la verbalizzazione
umana è un frammento della mente-cervello, non l’effetto di pratiche comunicative comunitarie. La
variabilità linguistica che appare in tutta evidenza nel visitare paesi assai diversi dal nostro è un
falso indizio di diversità: il contrasto di cui facciamo esperienza riguarda soltanto il codice espressivo,
la struttura di superficie del linguaggio. La sostanza della verbalizzazione umana, tuttavia,
è rintracciabile nella sua struttura profonda, la Grammatica Universale: l’insieme di regole e principi
che governano il funzionamento della mente-cervello nei processi di produzione e comprensione linguistica.
Quando spostiamo l’attenzione dal codice espressivo al dispositivo bio-cognitivo che
governa l’acquisizione e il corretto funzionamento delle nostre capacità verbali, la diversità linguistica
lascia il posto all’idea che il linguaggio sia una caratteristica universale (come la postura
eretta) della nostra specie.
A dar man forte a Chomsky contro il relativismo culturale è l’innatismo del linguaggio: la Grammatica
Universale è un dispositivo di elaborazione presente sin dalla nascita nella mente-cervello degli
umani. Tutto il percorso concettuale di Chomsky, in effetti, può essere considerato una difesa di ciò
che il linguista americano ha chiamato il «problema di Platone»: capire come dar conto di ciò che gli
umani sanno a partire dalle limitate esperienze che hanno. Il linguaggio non può essere spiegato in
termini di apprendimento perché lo stimolo verbale è troppo povero per giustificare le sofisticate
competenze linguistiche di cui (molto presto) dispone il bambino.
Gli argomenti di Chomsky rappresentano un punto di non ritorno: la Grammatica Universale ha chiamato
tutti gli studiosi a una reimpostazione di base del modo di guardare alla comunicazione umana.
Detto questo, la proposta di Chomsky è oggi al centro di una profonda revisione. Il primo fronte di
discussione riguarda il «fuoco amico»: le critiche, mosse da autori interni al paradigma chomskiano,
relative ai rapporti tra la Grammatica Universale e la teoria dell’evoluzione. Dall’altra parte della
barricata un secondo fronte di discussione riguarda la proposta dei neoculturalisti: studiosi che, in
nome della diversità delle lingue, attaccano frontalmente la natura innata e universale del linguaggio
umano. Entrambi i fronti di discussione sollevano questioni di grande importanza per il dibattito contemporaneo
e meritano alcune parole di commento.
Per comprendere le critiche alla Grammatica Universale mosse dal fronte interno, è necessario chiamare
in causa i rapporti che il modello chomskiano intrattiene con la tradizione cartesiana. Per
Chomsky il linguaggio è un fenomeno che non ha eguali in natura: la comunicazione umana (libera
e creativa) risponde a principi affatto diversi da quelli attribuibili alla comunicazione animale (meccanica
e determinata): seguendo Cartesio, Chomsky sostiene che il linguaggio istituisce una «differenza
qualitativa» tra gli individui della nostra specie e gli altri animali. Oltre a rinforzare l’idea
degli umani come entità speciali nella natura, la tesi dell’unicità del linguaggio umano offre a Chomsky
un appiglio per sostenere che il linguaggio non è un adattamento biologico dovuto alla selezione
naturale.
Il tema della complessità
Uno degli argomenti utilizzati da Chomsky contro la selezione naturale è l’idea che il linguaggio sia
«troppo complesso» per poter essere spiegato in termini gradualistici. Il tema della complessità,
come è noto, ha da sempre rappresentato un problema per la teoria dell’evoluzione. Al fondo della
questione è l’argomento degli organi incipienti utilizzato ai tempi di Darwin da St. George Mivart in
On the genesis of species (Mcmillan, 1871): se un’ala allo stato iniziale non permette di volare che
tipo di vantaggio può assicurare a un organismo? Discorso analogo vale per il linguaggio: quale vantaggio
adattativo può rappresentare un frammento iniziale di Grammatica Universale? Poiché senza
una risposta a queste domande non è possibile pensare a un’evoluzione gradualistica degli organi
complessi, la conclusione a cui perviene Chomsky è che la Grammatica Universale sia un dispositivo
tutto-o-nulla difficilmente conciliabile con la selezione naturale. A partire da queste considerazioni,
Chomsky fa propria la proposta avanzata da Ian Tattersall in Il cammino dell’uomo (Garzanti, 2004)
di considerare l’avvento del linguaggio in riferimento alla «teoria dell’esplosione»: secondo Tattersall,
in effetti, le capacità verbali umane sono emerse in modo «improvviso e inaspettato» molto di
recente nella storia di Homo sapiens.
Michael Corballis sostiene in The recursive mind (Princeton University Press, 2011) che considerare
la verbalizzazione umana un fatto improvviso e inaspettato sia un’ipotesi miracolistica che mal si
accorda con l’idea del linguaggio come un organo biologico. A conferma della tesi di Corballis è il
fatto che gli argomenti utilizzati da Chomsky contro la selezione naturale sono gli stessi di quelli
usati da Mivart: ora, come è possibile difendere un approccio naturalistico al linguaggio utilizzando
gli stessi argomenti usati da un fervente creazionista? Criticando aspramente Chomsky su questo
punto, Steven Pinker nel libro L’istinto del linguaggio (Mondadori, 1997) sostiene che, oltre a essere
pienamente compatibile con la Grammatica Universale, la selezione naturale è l’unica spiegazione in
campo (che non sia il creazionismo) per dar conto della complessità del linguaggio.
La risposta di Chomsky non è tardata ad arrivare. Rivedendo le proprie posizioni iniziali
sull’argomento, il linguista americano sostiene oggi che il linguaggio non è così complesso come
potrebbe sembrare: se si guarda al suo componente costitutivo essenziale (la facoltà di linguaggio in
senso stretto), è lecito considerare il linguaggio un’entità piuttosto semplice. Attraverso un’ipotesi
del genere, Chomsky è in grado di superare le difficoltà segnalate dai fautori della concezione adattazionista
del linguaggio senza cedere alle lusinghe di chi lo invita a rivedere il rapporto della Grammatica
Universale con la teoria darwiniana. Con il riferimento alla semplicità del linguaggio Chomsky
apre la strada al «minimalismo» (il suo ultimo modello teorico) convalidando una tendenza che,
storicamente, ha da sempre caratterizzato il suo percorso intellettuale: dagli anni Cinquanta del
Novecento a oggi, i diversi modelli interpretativi proposti da Chomsky sono stati contrassegnati da
un processo continuo di semplificazione. A vantaggio della semplificazione gioca la questione della
plausibilità cognitiva: se la Grammatica Universale descrive i principi alla base del funzionamento
della mente-cervello, allora la Grammatica Universale sarà tanto più plausibile quanto più semplici
ed economici (in termini di energia) saranno i principi che la descrivono. Detto questo, se le difficoltà
sottolineate dagli adattazionisti valgono soltanto per una concezione del linguaggio come un
organo di estrema complessità, attraverso il minimalismo Chomsky guadagna, oltre alla plausibilità
cognitiva, anche la plausibilità evoluzionistica della Grammatica Universale.
La natura della controversia
Il secondo fronte di critiche rispetto alla Grammatica Universale, il versante «neoculturalista», fa di
nuovo appello alla questione della diversità dei codici espressivi. Al tempo delle prime polemiche
contro il relativismo, Chomsky aveva avuto vita facile: i linguisti del tempo non avevano modelli plausibili
delle strutture e dei processi cognitivi implicati nella comunicazione umana. Oggi la situazione
è molto cambiata: nessuno studioso serio pensa di poter affrontare il tema della variabilità dei codici
espressivi senza una prospettiva adeguata dei dispositivi bio-cognitivi coinvolti nell’elaborazione del
linguaggio. Si pensi, solo per citare un esempio, al caso esposto da Michael Tomasello in Le origini
della comunicazione umana (Cortina, 2009) un autore da sempre impegnato nel tentativo di conciliare
gli aspetti culturali del linguaggio con l’idea che la comunicazione umana si avvalga di un ricco
(e in larga parte innato) sistema cognitivo di elaborazione.
Detto questo, la questione controversa è un’altra: più che l’innatismo o la natura universale di certi
dispositivi di elaborazione, il punto in discussione è capire se la Grammatica Universale debba
essere considerata l’unico dispositivo da chiamare in causa per spiegare il linguaggio; se essa sia
soltanto uno dei sistemi implicati nella comunicazione linguistica; o se, nell’ipotesi più radicale, il linguaggio
umano poggi su dispositivi di elaborazione del tutto diversi dalla Grammatica Universale.
La questione è aperta e, al momento, non è chiaro come rispondere al problema. Ciò che appare sensato
sostenere allo stato attuale della ricerca è che, in una prospettiva in cui trovi spazio l’idea del
linguaggio come ibrido bio-culturale, il tema della diversità delle lingue dovrà necessariamente convergere
con la teoria degli universali innati. In una prospettiva di questo tipo, indipendentemente
dalla direzione che prenderà la ricerca in futuro, il dato certo a nostra disposizione è che il confronto
con Chomsky rappresenta comunque un elemento imprescindibile della discussione.
Etichette:
Chomsky,
comunicazione,
Ferretti,
il manifesto,
linguaggio,
linguistica
13.1.14
Abbagli individuali e frodi volontarie
Vincenzo Barone (L'indice)
Silvano Fuso, La falsa scienza. Invenzioni folli, frodi e medicine miracolose dalla metà del Settecento a oggi, pp. 301, € 21, Carocci, Roma 2013
Più di mezzo secolo fa, il biologo e divulgatore francese Jean Rostand pubblicava un breve saggio intitolato Science fausse et fausses sciences (Gallimard, 1958) che aveva come oggetto “i vari modi in cui la verità scientifica può essere adulterata dagli ‘stregoni’ di ogni specie, dai fanatici di tutte le ideologie, e persino, inconsapevolmente, da qualche vero scienziato”. La “scienza falsa” è, nella terminologia di Rostand, quell’insieme di fenomeni illusori che alcuni scienziati, autoingannandosi, ritengono talvolta di osservare (l’esempio originale era quello dei raggi N di Blondlot, ma oggi possiamo far rientrare in questa categoria anche la memoria dell’acqua e la fusione fredda); le “false scienze” sono invece le credenze e le discipline genuinamente pseudoscientifiche, come la genetica di Lysenko o, a un livello più popolare, la rabdomanzia e le teorie della percezione extrasensoriale. Rostand vedeva in “un’igiene preventiva del giudizio” il modo più efficace di combattere le false scienze: “Insegnare ai giovani lo spirito critico, premunirli contro le menzogne della parola e della stampa, creare un terreno intellettuale in cui la credulità non possa attecchire, insegnare loro che cos’è coincidenza, probabilità, ragionamento giustificativo, logica affettiva, resistenza incosciente al vero, far loro comprendere che cos’è un fatto e che cos’è una prova”.
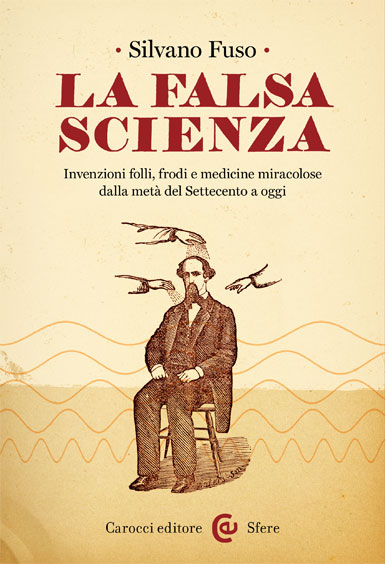 Dai tempi in cui Rostand denunciava gli attacchi preterintenzionali o dolosi alla verità scientifica, la scienza ha fatto passi da gigante, ma con essa è progredita anche la galassia della “parascienza”. È questo territorio variegato, fatto di teorie assurde, di leggende, di presunte scoperte, di risultati truffaldini, che il chimico e divulgatore Silvano Fuso esplora in un libro, La falsa scienza, che ricorda nel titolo il pamphlet di Rostand, ma si presenta come un repertorio sistematico e ragionato delle tante forme di “scienza malata”. Le sei parti in cui è suddiviso il libro illustrano altrettanti modi in cui la scienza può degenerare, o l’idea di scienza può essere declinata illegittimamente: abbagli individuali e collettivi, frodi volontarie, invenzioni folli, scoperte “metafisiche”, teorie rivoluzionarie, medicine e miracoli.
Dai tempi in cui Rostand denunciava gli attacchi preterintenzionali o dolosi alla verità scientifica, la scienza ha fatto passi da gigante, ma con essa è progredita anche la galassia della “parascienza”. È questo territorio variegato, fatto di teorie assurde, di leggende, di presunte scoperte, di risultati truffaldini, che il chimico e divulgatore Silvano Fuso esplora in un libro, La falsa scienza, che ricorda nel titolo il pamphlet di Rostand, ma si presenta come un repertorio sistematico e ragionato delle tante forme di “scienza malata”. Le sei parti in cui è suddiviso il libro illustrano altrettanti modi in cui la scienza può degenerare, o l’idea di scienza può essere declinata illegittimamente: abbagli individuali e collettivi, frodi volontarie, invenzioni folli, scoperte “metafisiche”, teorie rivoluzionarie, medicine e miracoli.
Fuso adotta l’espediente narrativo di fingere all’inizio di ogni capitolo che la pseudoteoria o la pseudoscoperta di cui si accinge a parlare siano corrette, e ne descrive, con esiti talvolta molto divertenti, le conseguenze. Che cosa succederebbe se la fusione fredda fosse un fenomeno reale, se gli animali telepatici di Rupert Sheldrake esistessero davvero, se il cronovisore di padre Ernetti potesse essere realizzato, se il raggio della morte attribuito a Nikola Tesla (uno degli scienziati che più alimentano le fantasie di mattoidi e ciarlatani) fosse nell’arsenale di qualche superpotenza?
 Luigi Di BellaIl gioco è particolarmente illuminante, perché le false scoperte non riguardano mai questioni di poco conto, ma sono sempre rivoluzionarie. Peccato, però, che di queste rivoluzioni non si veda in giro alcuna traccia. E qui entrano in scena altri due aspetti tipici della pseudoscienza: il mito del “genio incompreso” (il ricercatore solitario, spesso autodidatta, che nel chiuso della sua stanza scopre la teoria del tutto, o inventa la macchina del moto perpetuo) e la teoria del complotto (è, naturalmente, la scienza “ufficiale” a soffocare le straordinarie idee degli scienziati “eretici”). Molti dei casi trattati da Fuso inducono al sorriso, e sono preoccupanti solo perché segnalano un totale fraintendimento delle regole e delle procedure della scienza. Ma ce ne sono altri che destano allarme per le loro conseguenze etiche e sociali: si tratta, da un lato, dei casi di frodi scientifiche, sempre più frequenti vista la crescente competitività in certi settori della ricerca, come le biotecnologie e le nanoscienze; dall’altro, dei casi di terapie “non convenzionali” (ma sarebbe meglio dire infondate), che alimentano purtroppo le illusioni di persone in grave stato di difficoltà. Si pensi, a questo proposito, alla cura anticancro di Luigi Di Bella o, caso troppo recente per poter essere registrato dal libro di Fuso, al famigerato metodo Stamina dello psicologo Davide Vannoni: un protocollo oscuro, non sostenuto da alcuna sperimentazione controllata né da pubblicazioni scientifiche, oggetto di una domanda di brevetto corredata di figure tratte da ricerche altrui, e tuttavia improvvidamente magnificato da certi mezzi di comunicazione.
Luigi Di BellaIl gioco è particolarmente illuminante, perché le false scoperte non riguardano mai questioni di poco conto, ma sono sempre rivoluzionarie. Peccato, però, che di queste rivoluzioni non si veda in giro alcuna traccia. E qui entrano in scena altri due aspetti tipici della pseudoscienza: il mito del “genio incompreso” (il ricercatore solitario, spesso autodidatta, che nel chiuso della sua stanza scopre la teoria del tutto, o inventa la macchina del moto perpetuo) e la teoria del complotto (è, naturalmente, la scienza “ufficiale” a soffocare le straordinarie idee degli scienziati “eretici”). Molti dei casi trattati da Fuso inducono al sorriso, e sono preoccupanti solo perché segnalano un totale fraintendimento delle regole e delle procedure della scienza. Ma ce ne sono altri che destano allarme per le loro conseguenze etiche e sociali: si tratta, da un lato, dei casi di frodi scientifiche, sempre più frequenti vista la crescente competitività in certi settori della ricerca, come le biotecnologie e le nanoscienze; dall’altro, dei casi di terapie “non convenzionali” (ma sarebbe meglio dire infondate), che alimentano purtroppo le illusioni di persone in grave stato di difficoltà. Si pensi, a questo proposito, alla cura anticancro di Luigi Di Bella o, caso troppo recente per poter essere registrato dal libro di Fuso, al famigerato metodo Stamina dello psicologo Davide Vannoni: un protocollo oscuro, non sostenuto da alcuna sperimentazione controllata né da pubblicazioni scientifiche, oggetto di una domanda di brevetto corredata di figure tratte da ricerche altrui, e tuttavia improvvidamente magnificato da certi mezzi di comunicazione.
Il libro di Fuso si conclude con l’invito a un sano scetticismo, inteso non come incredulità aprioristica, ma come la giusta pretesa di avere prove adeguate prima di accettare un’asserzione. “Si tratta – osserva l’autore – di un atteggiamento mentale non solo perfettamente razionale, ma anche doveroso nella scienza e in qualsiasi altro ambito”. Da dove, se non da qui, dovrebbe prendere avvio l’educazione del cittadino nella società della conoscenza.
Etichette:
credulità,
frode,
invenzioni,
pensiero critico,
scienza
9.1.14
Rompere l’incanto neoliberale: Europa, terreno di lotta
di Sandro Mezzadra e Toni Negri (EuroNomade)
Chi come noi non ha interessi elettorali è nella migliore posizione per riconoscere la grande importanza che avranno, nel 2014, le elezioni per il parlamento europeo. È facile prevedere, nella maggior parte dei Paesi interessati, un elevato astensionismo e una significativa affermazione di forze “euroscettiche”, unite dalla retorica del ritorno alla “sovranità nazionale”, dall’ostilità all’euro e ai “tecnocrati di Bruxelles”. Non sono buone cose, per noi. Siamo da tempo convinti che l’Europa ci sia, che tanto sotto il profilo normativo quanto sotto quello dell’azione governamentale e capitalistica l’integrazione abbia ormai varcato la soglia dell’irreversibilità. Nella crisi, un generale riallineamento dei poteri – attorno alla centralità della BCE e a quel che viene definito “federalismo esecutivo” – ha certo modificato la direzione del processo di integrazione, ma non ne ha posto in discussione la continuità. La stessa moneta unica appare oggi consolidata dalla prospettiva dell’Unione bancaria: contestare la violenza con cui essa esprime il comando capitalistico è necessario, immaginare un ritorno alle monete nazionali significa non capire qual è oggi il terreno su cui si gioca lo scontro di classe. Certo, l’Europa oggi è un’“Europa tedesca”, la sua geografia economica e politica si va riorganizzando attorno a precisi rapporti di forza e di dipendenza che si riflettono anche a livello monetario. Ma solo l’incanto neoliberale induce a scambiare l’irreversibilità del processo di integrazione con l’impossibilità di modificarne i contenuti e le direzioni, di far agire dentro lo spazio europeo la forza e la ricchezza di una nuova ipotesi costituente. Rompere questo incanto, che in Italia è come moltiplicato dalla vera e propria dittatura costituzionale sotto cui stiamo vivendo, significa oggi riscoprire lo spazio europeo come spazio di lotta, di sperimentazione e di invenzione politica. Come terreno sul quale la nuova composizione sociale dei lavoratori e dei poveri aprirà, eventualmente, una prospettiva di organizzazione politica. Certo, lottando sul terreno europeo, essa avrà la possibilità di colpire direttamente la nuova accumulazione capitalistica. È ormai solo sul terreno europeo che possono porsi la questione del salario come quella del reddito, la definizione dei diritti come quella delle dimensioni del welfare, il tema delle trasformazioni costituzionali interne ai singoli paesi come la questione costituente europea. Oggi, fuori da questo terreno, non si dà realismo politico.
A noi pare che le forze di destra abbiano da tempo compreso che l’irreversibilità dell’integrazione segna oggi il perimetro di ciò che è politicamente pensabile e praticabile in Europa. Attorno a un’ipotesi di sostanziale approfondimento del neoliberalismo si è ormai organizzato un blocco egemonico che comprende al proprio interno varianti anche significativamente eterogenee (dalle aperture non solo tattiche in direzione di ipotesi socialdemocratiche di Angela Merkel alla violenta stretta repressiva e conservatrice di Mariano Rajoy). Le stesse forze di destra che si presentano come “anti-europee”, quantomeno nelle loro componenti più avvertite, giocano questa opzione sul terreno europeo, puntando ad allargare gli spazi di autonomia nazionale che nella costituzione della UE sono ben presenti e recuperando su un piano meramente demagogico il risentimento e la rabbia diffusi in ampi settori della popolazione dopo anni di crisi. Il riferimento alla nazione si dimostra qui per quel che è: la trasfigurazione di un senso di impotenza in aggressività xenofoba, la difesa di interessi particolari immaginati come architravi di una “comunità di destino”. Per contro la sinistra socialista, anche dove non è direttamente parte del blocco egemonico neoliberale, fatica a distinguersene in modo efficace e ad elaborare proposte programmatiche di segno chiaramente innovativo. La candidatura di Alexis Tsipras, leader di Syriza, a presidente della Commissione europea riveste in questo quadro un indubbio significato, e ha determinato in molti Paesi una positiva apertura di dibattito a sinistra, anche se in altri (primo fra tutti l’Italia) sembrano prevalere gli interessi di piccoli gruppi o “partiti”, incapaci di sviluppare un discorso politico pienamente europeo.
Se così stanno le cose, perché ci sembrano importanti le elezioni europee del prossimo maggio? In primo luogo perché tanto il relativo rafforzamento dei poteri del parlamento quanto l’indicazione da parte dei partiti di un candidato alla presidenza della Commissione fanno necessariamente della campagna elettorale un momento di dibattito europeo, in cui le diverse forze saranno costrette a definire e ad enunciare quantomeno un abbozzo di programma politico europeo. A noi pare dunque che si presenti qui un’occasione di intervento politico per tutti coloro che si battono per rompere tanto l’incanto neoliberale quanto il suo corollario, secondo cui l’unica opposizione possibile alla forma attuale dell’Unione Europea è il “populismo” anti-europeo. Non escludiamo in linea di principio che questo intervento possa trovare interlocutori tra le forze che si muovono sul terreno elettorale. Ma quello a cui pensiamo è prima di tutto un intervento di movimento, capace di radicarsi all’interno delle lotte che negli ultimi mesi si sono sviluppate, sia pure in forme diverse, in molti Paesi europei (cominciando a investire con significativa intensità anche la Germania). Decisivo è oggi riqualificare un discorso di programma, e solo dentro e contro lo spazio europeo questo è possibile. Non v’è oggi da indagare sociologicamente, magari all’ombra di qualche forcone, la “composizione tecnica di classe” nell’attesa messianica della “composizione politica” adeguata. Così come oggi non c’è da attendersi che si diano movimenti di classe vincenti che non abbiano interiorizzato la dimensione europea. Non sarebbe la prima volta, anche nella recente storia delle lotte, che taluni movimenti fossero obbligati dal modificarsi del quadro politico a ripiegare da grandi esperienze locali ad asfittiche chiusure settarie. Si tratta di ricostruire immediatamente un orizzonte generale di trasformazione, di elaborare collettivamente una nuova grammatica politica e un insieme di elementi di programma che possano aggregare forza e potere dall’interno delle lotte, contrapponendosi alle derive che abbiamo visto in Italia nelle scorse settimane, dove non a caso il simbolo unificante è stato il tricolore. Qui e ora, lo ripetiamo, l’Europa ci appare il solo spazio in cui questo sia possibile.
Un punto ci sembra particolarmente importante. La violenza della crisi farà sentire ancora a lungo i suoi effetti. All’orizzonte non c’è la “ripresa”, se per ripresa intendiamo un significativo riassorbimento della disoccupazione, la diminuzione della precarietà e un relativo riequilibrio dei redditi. Tuttavia, un ulteriore approfondimento della crisi sembra da escludere. L’accordo sul salario minimo su cui si è fondata la nuova grande coalizione in Germania pare piuttosto indicare un punto di mediazione sul terreno del salario sociale che può funzionare – a geometria e geografia variabili – come criterio di riferimento generale per la definizione di uno scenario di relativa stabilità capitalistica in Europa. È uno scenario, non è la realtà attuale, ed è uno scenario di relativa stabilità capitalistica. Sotto il profilo della forza lavoro e delle forme della cooperazione sociale, questo scenario assume come dati di partenza l’estensione e l’intensificazione della precarietà, la mobilità all’interno dello spazio europeo e dall’esterno, il declassamento di quote rilevanti di lavoro cognitivo e la formazione di nuove gerarchie all’interno di quest’ultimo, che si sono determinati nella crisi. Più in generale lo scenario di relativa stabilità di cui parliamo registra la piena egemonia di un capitale le cui operazioni fondamentali hanno una natura estrattiva, combinano cioè alla persistenza del tradizionale sfruttamento un intervento di “prelievo” diretto della ricchezza sociale (attraverso dispositivi finanziari ma anche assumendo come terreno privilegiato di valorizzazione “beni comuni” come, fra gli altri, la salute e l’istruzione). Non a caso i movimenti hanno compreso che su questo terreno si danno le lotte capaci di colpire il nuovo regime di accumulazione, come hanno mostrato in Italia il 19 ottobre.
Dentro questo scenario si tratta ovviamente di guardare alla specificità delle lotte che si sviluppano, di analizzarne l’eterogeneità e di misurarne l’efficacia in contesti politici, sociali e territoriali che possono essere anche molto diversi. Ma si tratta anche di porre il problema del modo in cui possono convergere, moltiplicando la loro stessa potenza “locale”, entro la cornice europea. La delineazione di nuovi elementi di programma può prendere intanto la forma della scrittura collettiva di una serie di principi inderogabili, sul terreno del welfare e del lavoro, della fiscalità e della mobilità, delle forme di vita e della precarietà, su tutti i terreni su cui si sono espressi e si esprimono i movimenti in Europa. Non è una carta dei diritti scritta dal basso, e da proporre a qualche assise istituzionale, quella a cui pensiamo: è piuttosto un esercizio collettivo di definizione programmatica che, come comincia a mostrare in queste settimane la stesura della “Carta di Lampedusa” per quel che riguarda la migrazione e l’asilo, può diventare strumento di organizzazione a livello europeo. Senza dimenticare che in questo lavoro possono sorgere impulsi decisivi, fin da subito, per la costruzione di coalizioni di forze locali ed europee, sindacali e mutualistiche, in movimento.
Chi come noi non ha interessi elettorali è nella migliore posizione per riconoscere la grande importanza che avranno, nel 2014, le elezioni per il parlamento europeo. È facile prevedere, nella maggior parte dei Paesi interessati, un elevato astensionismo e una significativa affermazione di forze “euroscettiche”, unite dalla retorica del ritorno alla “sovranità nazionale”, dall’ostilità all’euro e ai “tecnocrati di Bruxelles”. Non sono buone cose, per noi. Siamo da tempo convinti che l’Europa ci sia, che tanto sotto il profilo normativo quanto sotto quello dell’azione governamentale e capitalistica l’integrazione abbia ormai varcato la soglia dell’irreversibilità. Nella crisi, un generale riallineamento dei poteri – attorno alla centralità della BCE e a quel che viene definito “federalismo esecutivo” – ha certo modificato la direzione del processo di integrazione, ma non ne ha posto in discussione la continuità. La stessa moneta unica appare oggi consolidata dalla prospettiva dell’Unione bancaria: contestare la violenza con cui essa esprime il comando capitalistico è necessario, immaginare un ritorno alle monete nazionali significa non capire qual è oggi il terreno su cui si gioca lo scontro di classe. Certo, l’Europa oggi è un’“Europa tedesca”, la sua geografia economica e politica si va riorganizzando attorno a precisi rapporti di forza e di dipendenza che si riflettono anche a livello monetario. Ma solo l’incanto neoliberale induce a scambiare l’irreversibilità del processo di integrazione con l’impossibilità di modificarne i contenuti e le direzioni, di far agire dentro lo spazio europeo la forza e la ricchezza di una nuova ipotesi costituente. Rompere questo incanto, che in Italia è come moltiplicato dalla vera e propria dittatura costituzionale sotto cui stiamo vivendo, significa oggi riscoprire lo spazio europeo come spazio di lotta, di sperimentazione e di invenzione politica. Come terreno sul quale la nuova composizione sociale dei lavoratori e dei poveri aprirà, eventualmente, una prospettiva di organizzazione politica. Certo, lottando sul terreno europeo, essa avrà la possibilità di colpire direttamente la nuova accumulazione capitalistica. È ormai solo sul terreno europeo che possono porsi la questione del salario come quella del reddito, la definizione dei diritti come quella delle dimensioni del welfare, il tema delle trasformazioni costituzionali interne ai singoli paesi come la questione costituente europea. Oggi, fuori da questo terreno, non si dà realismo politico.
A noi pare che le forze di destra abbiano da tempo compreso che l’irreversibilità dell’integrazione segna oggi il perimetro di ciò che è politicamente pensabile e praticabile in Europa. Attorno a un’ipotesi di sostanziale approfondimento del neoliberalismo si è ormai organizzato un blocco egemonico che comprende al proprio interno varianti anche significativamente eterogenee (dalle aperture non solo tattiche in direzione di ipotesi socialdemocratiche di Angela Merkel alla violenta stretta repressiva e conservatrice di Mariano Rajoy). Le stesse forze di destra che si presentano come “anti-europee”, quantomeno nelle loro componenti più avvertite, giocano questa opzione sul terreno europeo, puntando ad allargare gli spazi di autonomia nazionale che nella costituzione della UE sono ben presenti e recuperando su un piano meramente demagogico il risentimento e la rabbia diffusi in ampi settori della popolazione dopo anni di crisi. Il riferimento alla nazione si dimostra qui per quel che è: la trasfigurazione di un senso di impotenza in aggressività xenofoba, la difesa di interessi particolari immaginati come architravi di una “comunità di destino”. Per contro la sinistra socialista, anche dove non è direttamente parte del blocco egemonico neoliberale, fatica a distinguersene in modo efficace e ad elaborare proposte programmatiche di segno chiaramente innovativo. La candidatura di Alexis Tsipras, leader di Syriza, a presidente della Commissione europea riveste in questo quadro un indubbio significato, e ha determinato in molti Paesi una positiva apertura di dibattito a sinistra, anche se in altri (primo fra tutti l’Italia) sembrano prevalere gli interessi di piccoli gruppi o “partiti”, incapaci di sviluppare un discorso politico pienamente europeo.
Se così stanno le cose, perché ci sembrano importanti le elezioni europee del prossimo maggio? In primo luogo perché tanto il relativo rafforzamento dei poteri del parlamento quanto l’indicazione da parte dei partiti di un candidato alla presidenza della Commissione fanno necessariamente della campagna elettorale un momento di dibattito europeo, in cui le diverse forze saranno costrette a definire e ad enunciare quantomeno un abbozzo di programma politico europeo. A noi pare dunque che si presenti qui un’occasione di intervento politico per tutti coloro che si battono per rompere tanto l’incanto neoliberale quanto il suo corollario, secondo cui l’unica opposizione possibile alla forma attuale dell’Unione Europea è il “populismo” anti-europeo. Non escludiamo in linea di principio che questo intervento possa trovare interlocutori tra le forze che si muovono sul terreno elettorale. Ma quello a cui pensiamo è prima di tutto un intervento di movimento, capace di radicarsi all’interno delle lotte che negli ultimi mesi si sono sviluppate, sia pure in forme diverse, in molti Paesi europei (cominciando a investire con significativa intensità anche la Germania). Decisivo è oggi riqualificare un discorso di programma, e solo dentro e contro lo spazio europeo questo è possibile. Non v’è oggi da indagare sociologicamente, magari all’ombra di qualche forcone, la “composizione tecnica di classe” nell’attesa messianica della “composizione politica” adeguata. Così come oggi non c’è da attendersi che si diano movimenti di classe vincenti che non abbiano interiorizzato la dimensione europea. Non sarebbe la prima volta, anche nella recente storia delle lotte, che taluni movimenti fossero obbligati dal modificarsi del quadro politico a ripiegare da grandi esperienze locali ad asfittiche chiusure settarie. Si tratta di ricostruire immediatamente un orizzonte generale di trasformazione, di elaborare collettivamente una nuova grammatica politica e un insieme di elementi di programma che possano aggregare forza e potere dall’interno delle lotte, contrapponendosi alle derive che abbiamo visto in Italia nelle scorse settimane, dove non a caso il simbolo unificante è stato il tricolore. Qui e ora, lo ripetiamo, l’Europa ci appare il solo spazio in cui questo sia possibile.
Un punto ci sembra particolarmente importante. La violenza della crisi farà sentire ancora a lungo i suoi effetti. All’orizzonte non c’è la “ripresa”, se per ripresa intendiamo un significativo riassorbimento della disoccupazione, la diminuzione della precarietà e un relativo riequilibrio dei redditi. Tuttavia, un ulteriore approfondimento della crisi sembra da escludere. L’accordo sul salario minimo su cui si è fondata la nuova grande coalizione in Germania pare piuttosto indicare un punto di mediazione sul terreno del salario sociale che può funzionare – a geometria e geografia variabili – come criterio di riferimento generale per la definizione di uno scenario di relativa stabilità capitalistica in Europa. È uno scenario, non è la realtà attuale, ed è uno scenario di relativa stabilità capitalistica. Sotto il profilo della forza lavoro e delle forme della cooperazione sociale, questo scenario assume come dati di partenza l’estensione e l’intensificazione della precarietà, la mobilità all’interno dello spazio europeo e dall’esterno, il declassamento di quote rilevanti di lavoro cognitivo e la formazione di nuove gerarchie all’interno di quest’ultimo, che si sono determinati nella crisi. Più in generale lo scenario di relativa stabilità di cui parliamo registra la piena egemonia di un capitale le cui operazioni fondamentali hanno una natura estrattiva, combinano cioè alla persistenza del tradizionale sfruttamento un intervento di “prelievo” diretto della ricchezza sociale (attraverso dispositivi finanziari ma anche assumendo come terreno privilegiato di valorizzazione “beni comuni” come, fra gli altri, la salute e l’istruzione). Non a caso i movimenti hanno compreso che su questo terreno si danno le lotte capaci di colpire il nuovo regime di accumulazione, come hanno mostrato in Italia il 19 ottobre.
Dentro questo scenario si tratta ovviamente di guardare alla specificità delle lotte che si sviluppano, di analizzarne l’eterogeneità e di misurarne l’efficacia in contesti politici, sociali e territoriali che possono essere anche molto diversi. Ma si tratta anche di porre il problema del modo in cui possono convergere, moltiplicando la loro stessa potenza “locale”, entro la cornice europea. La delineazione di nuovi elementi di programma può prendere intanto la forma della scrittura collettiva di una serie di principi inderogabili, sul terreno del welfare e del lavoro, della fiscalità e della mobilità, delle forme di vita e della precarietà, su tutti i terreni su cui si sono espressi e si esprimono i movimenti in Europa. Non è una carta dei diritti scritta dal basso, e da proporre a qualche assise istituzionale, quella a cui pensiamo: è piuttosto un esercizio collettivo di definizione programmatica che, come comincia a mostrare in queste settimane la stesura della “Carta di Lampedusa” per quel che riguarda la migrazione e l’asilo, può diventare strumento di organizzazione a livello europeo. Senza dimenticare che in questo lavoro possono sorgere impulsi decisivi, fin da subito, per la costruzione di coalizioni di forze locali ed europee, sindacali e mutualistiche, in movimento.
1.1.14
Ricerca italiana tra le più citate. Ma fanno notizia solo le classifiche negative
CLASSIFICHE INTERNAZIONALI
Ricerca italiana tra le più citate. Ma fanno notizia solo le classifiche negative
Posted by Francesco Sylos Labini on 1 gennaio 2014 at 11:01 [roars.it]
Questa è una notizia, apparsa sulla rivista Nature, che non è passata sui giornali italiani. La riporto per intero:
Gli Stati Uniti stanno scivolando verso il basso nella classifica della qualità della ricerca, misurata attraverso l’impatto citazionale relativo dei suoi articoli [scientifici]. Questo è quanto viene mostrato da uno studio commissionato dal governo britannico. In particolare, gli analisti della casa editrice Elsevier mostrano che gli Stati Uniti sono stati superati nella classifica (normalizzata per disciplina) dal Regno Unito nel 2006 e dall’Italia nel 2012, anche se gli Stati Uniti rimangono ben avanti in termini di quota mondiale del top 1% degli articoli più citati.
In pratica significa che il surrogato della misura della qualità della ricerca, rappresentato dal numero di volte che un articolo scientifico è stato citato, per l’Italia ha superato l’analogo indicatore per gli Stati Uniti – fermo restando che quest’ultimi sono avanti quando si considera solo l’1% degli articoli più citati.
Inoltre dallo stesso studio si trova anche che l’efficienza della ricerca italiana è ottima: ad esempio il numero di citazioni ottenute per unità di spesa in ricerca e sviluppo è secondo solo al Regno Unito e pari a quello Canadese, dunque maggiore di Francia, Germania, Usa, ecc. Certamente questo studio si riferisce solo a quei campi che vengono censiti dalle banche dati bibliometriche come Scopus: ma questi includono tutte le discipline tecnico-scientifiche e bio-mediche, dunque si tratta di un dato assolutamente rilevante.
Insomma questo dovrebbe essere un risultato riportato con una certa visibilità: finalmente un settore in cui primeggiamo, addirittura se rapportati agli Usa, oltre che essere sempre avanti nelle classifiche dei paesi più corrotti, ecc. E invece nessuno ne parla: perché? Perché invece appena esce una nuova classifica delle università, in cui notoriamente gli atenei italiani non occupano le prime posizioni, se ne parla su tutti i giornali, il ministro di turno promette interventi drastici per riportare in vita la ricerca e l’accademica italiana, ogni volta additati per la sentina dei vizi nazionali?
In realtà dovrebbe accadere il contrario. Infatti, le classifiche basate sulle citazioni di articoli scientifici riportano un dato piuttosto affidabile poiché confrontano, per macro-insiemi di ricercatori, un indicatore semplice da misurare, in determinate banche dati, e relativamente rilevante. Considerando che inoltre la spesa complessiva per l’istruzione superiore in Italia è un terzo di quella degli Usa (metà della Francia, Germania, ecc.) bisognerebbe riconoscerel’efficienza del sistema, nonostante che i docenti di ruolo siano i più anziani dei paesi sviluppati, che gruppi di pressione possano agire con la complicità della politica e che fenomeni di malcostume siano piuttosto frequenti nella gestione dei ruoli di potere accademico.
Invece le classifiche delle università confrontano pere con mele: sono stilate in basi a criteri piuttosto arbitrari, non hanno consistenza scientifica poiché la posizione è calcolata in base ad un mix di parametri del tutto questionabili (dalla produzione scientifica, al numero di studenti per docenti) e soprattutto non tengono conto di un non marginale dettaglio. Per capire quale basti ricordare che nel 2012 le spese operative della sola università di Harvard, frequentata da qualche decina di miglia di studenti, solitamente ai primi posti di queste classifiche, equivalgono al poco meno della metà di tutto il fondo di finanziamento ordinario dell’intera università italiana: il problema non è che Harvard sia prima, il problema sarebbe che non lo fosse!
Etichette:
classifiche internazionali,
Labini,
Nature,
ricerca,
roars,
università
Iscriviti a:
Post (Atom)


