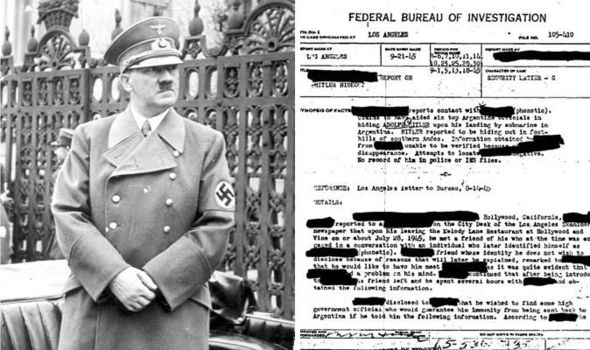Il 10 febbraio a Pavia l’«Arca delle virtù», il primo convegno internazionale dedicato alla «Speranza».
Qui pubblichiamo in anteprima l’intervento della psicologa
Silvia Vegetti Finzi (
Corriere)
Nella riflessione di Agostino la speranza, non solo occupa un posto centrale, ma costituisce l’elemento dinamico, il motore che anima il suo sistema filosofico. Quando definisce il tempo come «tensione dell’anima», riconosce nella speranza il vettore che congiunge la storia umana all’eternità, la città terrestre alla città celeste, l’attesa alla felicità. Una felicità inscritta nel piano divino della salvezza ma profondamente radicata nell’esistenza umana. Mentre per Paolo di Tarso la speranza è un dono di Dio, della sua grazia, Agostino ne coglie le premesse nel cuore stesso dell’uomo, nella sua interiorità. Nella nostra memoria profonda sussiste infatti l’impronta di una felicità totale, una condizione che non abbiamo mai sperimentato, ma che tende a essere ripristinata . La pretesa di riottenere ciò che non c’è più e non c’è ancora fa della speranza una manifestazione del desiderio. Un desiderio instabile e turbolento che richiama, forzando l’analogia, il modello di inconscio teorizzato da Freud. In ambito teologico poi, allacciando la speranza alla carità, Agostino ne sottolinea la dimensione affettiva e relazionale, l’apertura all’altro che essa comporta.
Ma per comprendere appieno la rivoluzione provocata dalla filosofia morale di Agostino dobbiamo confrontarla con la tarda concezione pagana, rappresentata dallo stoicismo. Per il saggio stoico, incarnato nella figura dell’intellettuale aristocratico, la felicità consiste nell’ esercizio della virtù, intesa come controllo delle componenti irrazionali dell’anima.
Scopo della virtù è raggiungimento di uno stato di atarassia, di imperturbabile calma, capace di sottrarre l’uomo tanto all’impeto delle passioni quanto alle contrarietà del destino. Saggio è colui che, inscrivendo la propria vita nell’ordine necessario del mondo, vuole ciò che accade. A quella sobria, rinunciataria promessa, Agostino contrappone una felicità totale, incondizionata ed eterna, non qui, sulla terra, ma nell’al di là, quando la misericordia divina accoglierà in cielo l’umanità redenta. La sua promessa si rivolge a tutti , anche e soprattutto a chi non ha altra speranza che la speranza stessa. Siamo nel IV secolo, negli anni tragici della caduta dell’impero romano, anni di decadenza materiale e morale che culmina nel sacco di Roma da parte dei Goti di Alarico nel 410. La crisi di un’epoca che molti storici paragonano alla congiuntura negativa che stiamo vivendo.
Nella concezione agostiniana sperare non consiste soltanto nell’attesa passiva di un premio. Comporta piuttosto un soggetto attivo, propositivo, capace di orientare l’impeto dei desideri verso la verità e il bene. Il verbo «sperare» non conosce il passivo, nessuno può essere «sperato» da un altro.
Il fatto che la speranza nasca nel cuore dell’uomo e sia gestita in prima persona da un soggetto desiderante la rende particolarmente suscettibile a una progettualità educativa. Così intesa, la formazione alla speranza si propone innanzitutto di propiziare sentimenti di fiducia, atteggiamenti positivi verso se stessi e gli altri, di suscitare e alimentare l’inclinazione ad andare oltre, a cambiare le cose, a individuare nuovi percorsi e nuovi fini.
A questo scopo le parole del maestro non sono determinanti, hanno solo una funzione di stimolo perché la verità è raggiungibile, secondo Agostino, con procedure introspettive, con pratiche di conoscenza di sé, diremmo ora con l’autoanalisi e l’autobiografia. Ora, nella tarda modernità, dopo l’eclisse del futuro provocata dalla secolarizzazione della società e dal crollo delle grandi utopie del Novecento, una pedagogia della speranza s’impone come un compito ineludibile. Il persistere di una grave crisi, economica e morale, sembra aver deprivato l’orizzonte di promesse, abbassato il livello delle attese, compresso il futuro nelle anguste dimensioni del presente.
Eppure, come aveva rilevato Agostino, persiste nel cuore umano una pretesa di felicità che non si lascia appagare da soddisfazioni parziali e contingenti. Ed è da questo inesauribile afflato che può prendere le mosse, nell’epoca della morte di Dio e della fine della storia, un progetto di educazione morale. L’incapacità, tanto di evocare un futuro ultraterreno, quanto di proporre scenari storici di grandi proporzioni, riporta la morale contemporanea alla sobrietà dell’etica stoica, all’esercizio di una virtù individuale, cui sono predisposti tutti gli uomini in quanto animali razionali.
Tuttavia nei secoli che ci separano dall’antichità, molte cose sono cambiate. le nostre esperienze e conoscenze, la stessa percezione che abbiamo di noi stessi, ci impediscono di nutrire, nella ragionevolezza umana, la fiducia dei filosofi antichi.
Il romanticismo ha riconosciuto, nel caos delle passioni, nell’irrazionalità dei sentimenti, non una deviazione, ma una manifestazione della natura umana. E, nel Novecento, la contrapposizione tra ragione e passione è stata riformulata, nella concezione psicoanalitica, come interazione tra conscio e inconscio, pulsioni e censure, Eros e Thanatos.
L’uomo classico, padrone di sé e del mondo, secondo l’immagine leonardesca, si è trasformato in un soggetto impigliato nelle sue contraddizioni, un individuo debole, suggestionabile, dominato da quelle che Spinoza definiva le «passioni tristi»: stati d’animo d’ impotenza, stanchezza, sfiducia che lo inducono a vivere nella paura rinunciando alle risorse della speranza.
Il una modernità «liquida», secondo la nota definizione di Baumann, incapace di emergere dai flussi della quotidianità , risulta impossibile rappresentare quanto non c’è ancora, prevedere l’avvenire, confidare nei vantaggi di un progresso inarrestabile. I desideri, privi di uno schermo sul quale proiettare attese e previsioni, ricadono inerti nelle angustie del presente. E all’individuo, solo e spaventato, non resta che consegnare la realizzazione dei suoi incompiuti desideri ai discendenti più prossimi, figli e nipoti. L’educazione morale diviene così un compito privato, centrato sulle aspettative dell’ educatore più che sulle potenzialità dell’educando.
Spaventata da un domani imprevedibile e minaccioso, la famiglia contemporanea cerca in ogni modo di difendere i figli dal fallimento esistenziale assicurando loro sicurezza, benessere e, se possibile, successo sociale. Addestrati sin dall’infanzia alla competizione e alla lotta da genitori trasformati in allenatori, i bambini attuali vivono in modo radicalmente diverso dalle generazioni precedenti.
I rischi d’insuccesso in una gara che contrappone tutti a tutti si rivelano duramente nel costante incremento, che supera ormai il 20%, degli inattivi di età compresa tra i 14 e i 24 anni. Ragazzi «né né», che non studiano e non lavorano, non desiderano e non pensano. In uno stato di anestesia esistenziale, non chiedono nulla a nessuno, tanto meno a se stessi. Gli adulti li supplicano con angoscia di uscire dall’isolamento, di tornare tra noi. Ma l’appello non viene recepito e migliaia di giovani , gli occhi puntati allo schermo, le orecchie sigillate dagli auricolari, la bocca silenziata dalla mancanza di domande, rimangono vicini, a portata di mano, eppure lontani come extraterrestri intravisti dall’oblò di un’astronave.
Incapaci di infrangere uno stato di esasperato solipsismo, di abbandonare circuiti di pensiero che, come nella reversibilità dei videogiochi, procedono privi di scopo e di senso, gli auto-sequestrati si limitano a sopravvivere.
Umberto Galimberti li descrive così: «…virtuosi dell’irresponsabilità, senza alcun riguardo per la propria storia personale, senza rispettare impegni e senza temere le eventuali conseguenze del proprio agire, dal momento che tutte le scelte sono disponibili e quelle effettuate tutte revocabili». «Il mondo non mi chiede niente», lamenta un’adolescente che, apparentemente ha tutto, anche troppo, salvo un motivo, uno solo, per abbandonare la sua cameretta.
In una società che non sa prospettare un futuro possibile e desiderabile, alle ultime generazioni si presentano due alternative: lottare per l’affermazione di sé, il successo e il prestigio affrontando una competizione feroce, oppure gettare la spugna, scendere dal ring della vita lasciando che i giorni fluiscano nell’indifferenza, nella noia, nel vizio antico dell’accidia.
In entrambi i casi assistiamo a un collasso della speranza, svanita insieme al catalogo delle passioni e delle virtù. Per fortuna tra questi due estremi si collocano tanti adolescenti e giovani alla ricerca di un’autentica realizzazione di sé, di una vita non fine a se stessa, spesa alla conquista di un successo effimero, ma finalizzata alla costruzione di un futuro positivo per tutti.
A tal fine l’educazione, se non intende ridursi a strumentale trasmissione di contenuti e di metodi, deve mirare a cambiare le disposizioni interiori dei ragazzi, l’animo oltre che il mondo. Non basta allora dichiarare i valori che la orientano, ma occorre giustificarli e testimoniarli: «dite quello che fate e fate quello che dite», avverte la grande psicoanalista Françoise Dolto. Solo la testimonianza rende vive e vere le dichiarazioni di principio, facili da enunciare, difficili da realizzare. Non si tratta di imporre, come in passato, comportamenti prefissati, né di indurre un galateo della vita, ma di promuovere atteggiamenti di fiducia e di speranza, gli unici capaci di costruire saldi progetti di felicità. Infranti gli stampi della tradizione, spetterà poi a ciascuno scegliere la meta da raggiungere e la strada da intraprendere.
Come primo passo occorre però che gli educatori, superando la paura, concedano ai bambini progressivi margini di autonomia e di indipendenza, possibilità di valutazione, di scelta e di dissenso. La speranza è un arbusto che cresce libero e spontaneo: nessuno spera per dovere o per forza. Non si tratta di un lascito testamentario ma di un obiettivo da prefigurare e perseguire liberamente. In questi anni invece i piccoli crescono in un regime di massima sicurezza che controlla ossessivamente spazi e tempi della loro vita. Lo sguardo degli educatori non li abbandona mai: l’agenda che scandisce la loro giornata non prevede fessure di autonomia. Fin da piccoli seguono un circuito obbligato: casa—scuola—compiti— tempo libero (che meno libero non potrebbe essere)—rientro a casa, cena e buonanotte.
Sono bambini buoni, troppo buoni, bambini che non sbagliano mai: e come potrebbero? Sottratti a ogni rischio, non conoscono le ginocchia sbucciate, ma neppure le potenzialità del loro corpo. Eppure senza tentare, mettersi alla prova, sbagliare e ricominciare, non saranno mai in grado di cavarsela da soli. La vita s’impara solo vivendo.
Spesso le mamme sono così adesive da diventare confusive. Parlando della scuola dicono:«adesso andiamo a fare in compiti», «dobbiamo impegnarci di più», «sono certa che ce la faremo». E il fragile Io del figlio resta così soffocato da un’indistinzione che non gli consente di disegnare i confini della sua identità, di distinguere tra sé e l’altro, tra dentro e fuori, tra le speranze proprie e altrui. Di fronte alle scelte della vita (il ciclo di studi, il progetto professionale, ma anche gli amici, lo sport, le lingue straniere, i viaggi, il partner) sono sempre di più i genitori che avocano a sé ogni decisione: «perché iscriversi al Classico quando lo Scientifico è più conveniente? ; «è’ assurdo fare l’attore, meglio il notaio», «perché seguire l’Erasmus a Barcellona quando Londra offre più possibilità?» e via di seguito. Nessuna considerazione per i talenti, gli hobby, i desideri, le aspirazioni del figlio. Ma un’educazione morale è anche una educazione sentimentale, che riconosce e sostiene le inclinazioni personali, che insegna ad agire ma anche a sentire nel modo giusto.
Invece il timore dell’insuccesso è tale da giustificare ogni prevaricazione sul figlio, esercitata per il suo bene naturalmente, sebbene nessuno sappia quale sia il bene del ragazzo se non lui stesso. Lo si deve informare, consigliare, ma infine spetta a lui scegliere quando partire, la rotta da seguire , il porto da raggiungere.
La speranza è un potenziale della gioventù ma, se viene confiscata dagli adulti, ogni possibilità di esprimersi si devitalizza: la tensione si smorza e il futuro si rattrappisce.
Finite le utopie dell’Uomo nuovo, che offrivano immagini e parole collettive, ciascuno, divenuto l’intellettuale di se stesso, è chiamato a delineare il proprio futuro. Ma, per pensare ciò che ancora non c’è, per dare un volto alla felicità, per tratteggiare percorsi mai percorsi, occorre usare la fantasia, l’immaginazione, il sogno ad occhi aperti. Come dice Moni Ovadia: «Abbiamo bisogno di sogni per sentirci svegli».
Invece diffidiamo della fantasia: temiamo che ci distolga dalla realtà, che evochi l’irrazionale e , oltrepassando i limiti, ci induca all’eccesso. Ci affidiamo piuttosto alla ragione calcolante, a una razionalità tecnica e burocratica che procede automaticamente, in modo neutro e impersonale, senza interrogarsi sui fini, senza controllare i mezzi che utilizza arbitrariamente.
La lezione dell’Olocausto, avverte Bauman, insegna che quell’orrore sarebbe stato impensabile e inattuabile senza l’indifferenza morale indotta dalla ragione strumentale. La burocrazia e la tecnica, che esprimono il più alto livello di efficienza raggiunto dalla civiltà occidentale, hanno frammentato le responsabilità sino a produrre la «banalità del male» di cui parla Hanna Arendt. La responsabilità morale può essere assunta solo da un soggetto che, emancipato dalla dipendenza infantile, riconosce il suo desiderio e risponde delle sue azioni.
Il desiderio va oltre il semplice appagamento del bisogno. Sollecitato dalla mancanza, non ha motivo di esistere quando, ancor prima di tradursi in domanda, viene saturato da offerte improprie e premature. I genitori che dicono «a mio figlio non faccio mancare niente», non sanno, certo in buona fede, che lo stanno privando della capacità di aspettare, della risorsa di sperare. Se il desiderio rimane privo di motivazioni, di tensioni, di atteggianti critici e selettivi, si ripiega su se stesso sino a divenire «desiderio di desiderio», malinconico rimpianto di una pienezza perduta. vero che la speranza si proietta nel futuro ma le sue radici affondano nel passato: senza immagini tratte dagli archivi della memoria individuale e collettiva non c’è prefigurazione di ciò che vorremmo avvenisse. Noi lavoriamo inevitabilmente con materiali che ereditiamo da un vasto e complicato repertorio che è alle nostre spalle, osserva Salvatore Veca. L’autobiografia per l’individuo e la storia per l’umanità sono il repertorio da cui la speranza trae il materiale con cui prefigurare il futuro.
Poiché il mondo cambia in fretta, il futuro che la speranza anima e sostiene non può tuttavia essere una ripetizione del passato. L’avvenire è sempre qualche cosa di nuovo, di sorprendente, d’inatteso.
Ed è nel flusso della narrazione, intesa come costruzione, che la speranza si mantiene viva. Per questo è importante, nell’epoca degli Io multipli, che la nostra fragile identità sia ricomposta da un soggetto narrante che, collegando il passato al futuro, appronti lo schermo sul quale proiettare possibili, desiderabili attese. Tuttavia le speranze non sono necessariamente positive, può sempre accadere che il risentimento, l’invidia, l’odio e il rancore le indirizzino verso il male. Come tutte le passioni, sono composite e ambivalenti, tanto che la speranza degli uni può corrispondere alla paura degli altri. Per questo Papa Francesco, definendo la speranza «una virtù rischiosa», ci mette in guardia dalle sue ingannevoli lusinghe.
In questi anni sta drasticamente diminuendo la capacità di pensare un futuro collettivo, di immaginarlo al di fuori dalle aspettative private, spesso fragili e inconsistenti. Ma, se gli ideali religiosi e civili perdono la loro funzione di orientamento, le scelte e i comportamenti restano affidati a una gestione conflittuale e predatoria dell’io e del mio che risulta reciprocamente distruttiva. Perché la speranza di felicità diventi realtà è necessario coniugare il verbo «sperare» nella forma plurale del noi: nessuno può essere felice se gli altri sono infelici. Solo in una società giusta e solidale, aperta e accogliente, volta al bene comune, le speranze individuali possono armonizzarsi con quelle collettive. Agostino confida nell’Ordo amoris, l’amore divino che, verticalizzando il tempo, ricompone i frammenti del mondo e mette ordine nelle fratture della storia, della vita individuale, del passato e del futuro. A un’analoga speranza sembra richiamarsi Freud quando, concludendo il saggio su Il disagio della civiltà, di fronte al pericolo incombente del nazismo, confida nel trionfo dell’amore contro l’odio, l’altra delle «due potenze celesti».
L’epoca in cui viviamo reclama grandi cambiamenti ma il tragico fallimento di tante utopie ci ha impedisce di immaginare un futuro eroico e grandioso inducendoci a giustificare l’esistente solo per il fatto di esistere. La rassegnazione, non la disperazione, è oggi il più forte antidoto alla speranza. Nel crepuscolo del futuro, mentre incombe l’oblio, dobbiamo cercare di comprendere come i conflitti e le tragedie del passato si sono composti nella mappa del presente e quali cicatrici segnano tuttora la coscienza contemporanea… E, insieme, ragionare su quali speranze possano far sì che la storia non appaia come un processo già determinato, una coazione senza riscatto.
«Oggi, scrive Luigi Zoja, nessuno può illudersi di far trionfare il bene. Ma chi non lotta contro le degenerazioni del nostro tempo, perché il compito non è glorioso né epico, manca di vero coraggio».